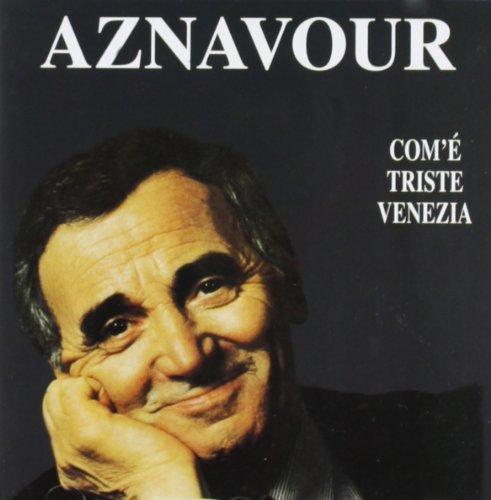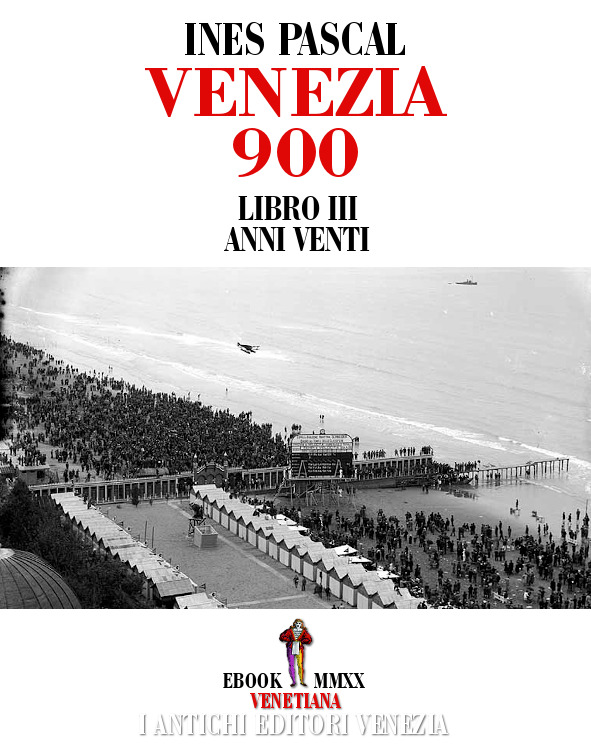Ma com’è triste Venezia
solo cinquant’anni dopo
Epitaffio lagunare nell’anniversario dell’alluvione
Com’è triste Venezia soltanto cinquant’anni dopo. Tanti ne sono passati dalla tragica alluvione che affondò la Serenissima il quattro di novembre del millenovecentosessantasei. Cinquant’anni passati invano. Cinquant’anni di chiacchiere, imbrogli e malaffare. La città è ancora indifesa di fronte al rischio di nuove inondazioni. In compenso sono arrivate altre e più temibili alluvioni, come quella dei trenta milioni di turisti che invadono e devastano la città che fu dei Dogi stravolgendone i connotati.
Negli ultimi cinquant’anni Venezia ha perso un terzo dei suoi abitanti e ha chiuso quasi tutte le sue attività, tranne quella del turismo. Un turismo sempre più volgare, cialtrone, e sempre più insopportabile per numeri e comportamenti. Pensare che l’allarme suscitato nel mondo dall’acqua granda del ’66 mosse il governo italiano a dichiarare la questione Venezia “di preminente interesse nazionale” e a intraprendere la strada del più grande intervento pubblico mai compiuto dallo Stato: la salvezza della città attraverso la sua salvaguardia fisica e la sua “rivitalizzazione socioeconomica”.
Il primo di questi due obiettivi, la salvaguardia fisica, non è stato ancora raggiunto. Il secondo, la rivitalizzazione socioeconomica, è stato clamorosamente mancato. Il parlamento italiano aveva impiegato sette anni, dopo l’alluvione, per varare la prima legge speciale per Venezia. Era il 1973, e venivano stanziati trecento miliardi di lire. Una cifra che all’epoca pareva un’esagerazione. Nei cinquant’anni successivi lo Stato italiano ha riversato su Venezia la cifra folle, questa davvero sì, di undici miliardi di euro (la stima, più che attendibile, è del professor Ignazio Musu dell’università veneziana di Ca’ Foscari), metà dei quali per il sistema di dighe mobili chiamato Mose, affondato dagli scandali e dalle tangenti, che nessuno sa quando verrà completato (ammesso che venga completato), e che avrebbe dovuto essere ultimato nel 1995(!), parola del presidente del consiglio Bettino Craxi nel 1989: “Non ammetteremo alcun ritardo”.
Ciò nonostante i politici veneziani di oggi, siano rapaci, siano incapaci, continuano a chiedere allo Stato soldi per Venezia. Altro non sanno dire, pensare, inventare, progettare. C’è un’idea sola: “Fora i schei”, sbraitano. Basta. Dopo aver buttato in laguna undici miliardi senza aver ottenuto alcun risultato, uno Stato serio dovrebbe avere l’intelligenza e il coraggio di dire che a Venezia non va più data una lira. Né oggi né domani né mai. Dovrebbe chiedere piuttosto, ai ladroni e agli inetti, la restituzione delle somme inutilmente stanziate. “Indrìo i schei”! Altro che “fora i schei”.
Nel frattempo, stretta fra dispute imbecilli, inutili e feroci, di fronti del si e fronti del no, gli uni contro gli altri stupidamente armati, la città ha cambiato volto. E non in meglio. Senza che nessuno facesse nulla, e nessuno ha fatto nulla, ha trovato la sua strada. Quasi per inerzia. Per la legge non scritta ma micidiale del libero mercato. Ha smesso, ormai quasi del tutto, di essere una città, una città normale, ed è diventata una quinta di teatro, un parco storico di divertimenti grande come tutta quanta la città, da aprire il mattino quando arrivano i turisti, da chiudere la sera quando se ne vanno. Benvenuti a Veneland. Il destino che nessuno voleva si è oramai quasi compiuto.
Nella vetrina della farmacia Morelli, in campo San Bortolomio, ai piedi del ponte di Rialto, c’è un display luminoso che aggiorna di minuto in minuto il numero degli abitanti. Oggi sono cinquantaquattromila. Cinquant’anni fa erano il triplo, centocinquantamila, e le antiche cronache raccontano che nel ‘400 ce n’erano addirittura quattrocento e cinquanta mila. Non c’è un anno, dall’alluvione ad oggi, che il movimento demografico degli abitanti non abbia il segno meno. Da mille a duemila veneziani in meno ogni anno. E l’esodo continua. Fra trent’anni, dicono gli esperti, a Venezia non ci saranno più abitanti. Solo turisti.
Chi se n’è andato via, lo ha fatto per emigrare verso i paesi della vicina terraferma, dopo che per l’alluvione vennero dichiarati inabitabili diciassettemila pianiterra in cui vivevano cinquantamila persone. Specialmente i giovani sono fuggiti. Per gli alti costi dell’affitto, dell’acquisto e del restauro delle case, che i veneziani stessi che ne sono proprietari, preferiscono affittare, spesso in nero, e vendere ai turisti. Lo sviluppo del turismo ha fatto andare alle stelle i prezzi degli immobili, riservati ormai solo ai ricchi. E l’esodo non ha colpito solo gli abitanti. Anche le imprese. Venezia non ha più una fabbrica (ne aveva, ne aveva), né un’attività produttiva che non sia quella di vendere un letto per una notte o un tavolo per una cena in una pessima osteria. Si è consegnata, legata mani e piedi, al nume tutelare del turismo. L’unico rimasto. Quello che la travolge, la soffoca e la uccide.
Basta vedere che hanno mestamente chiuso uno dopo l’altro, come vittime di un’epidemia, i negozi che in una città normale segnano la vita di tutti i giorni. Hanno chiuso panettieri, lattai, macellai, pescivendoli, calzolai, sarti e merciaie. Biavariòli, frutariòli e luganeghèri. Perfino osterie. Al loro posto hanno aperto boutiques grandi firme, fast food, botteghe di maschere finte fabbricate a Taiwan, falsi vetri di Murano, finti merletti di Burano. La città è caduta in mano ad affaristi senza scrupoli. Alla cricca degli albergatori e degli osti da rapina, degli intromettitori e dei battitori abusivi, dei motoscafisti, dei gondolieri, e dei bancarellari. Buoni ultimi, e ci mancavano solo quelli, i venditori abusivi di borse tarocche, bastoncini da selfie, rose appassite, dardi luminescenti e raggi laser.
E’ diventata una città dove il piacere di passeggiare non è più un piacere. Dove si mangia malissimo (salvo rare, preziose eccezioni), e si spende moltissimo. Dove il fascino di un tempo, che incantava le anime elette, è diventato sottile sottile, ormai quasi impalpabile. Come cipria leggera. Dove le cucine dei ristoranti chiudono alle dieci della sera (quando va bene), perché hanno guadagnato abbastanza durante il giorno. Dove tutti sono scortesi. Dove non è rimasto più neanche un cinema, in questa che è la città del cinema (salvo due sale gestite dal Comune), dove sono rimasti un solo teatro lirico e un solo teatro di prosa dove una commedia non può stare in scena più di due giorni perché non ci va nessuno. Dove l’unica cultura dominante è lo sfruttamento intensivo del turista. Dove i giovani scappano. Dove i pochi abitanti rimasti invecchiano rassegnati alla sconfitta.
Fino a qualche anno fa mi piaceva ancora la sera. D’inverno. Quando tramontano le luci del parco giochi, si spengono le insegne dei bar e dei negozi, e restano accesi solo i pallidi lumini dei fanali, e quando cammini piano, senza saper dove andare, senza nessuno che ti aspetta, il bavero alzato e le mani in tasca, e senti l’eco dei tuoi passi che schiacciano le pietre vecchie del selciato. Perché c’è un muro da qualche parte, lì vicino, che ti rimanda l’eco. Ma basta che superi quel muro, che sali i gradini di un ponte, che guardi giù in quell’acqua nera, e anche le tue scarpe non fanno più rumore. Non c’è più l’eco. Non ci sono più neanche le tue scarpe.
Non ci sei più neanche tu Venezia. Non mi piaci più. Sei triste come cantava Aznavour. E come cantava Morandi, me ne vado da te. Ciao Venezia ciao.
LA PAGELLA
Venezia: voto 4
Mose: voto 2
Aznavour: voto 8
Morandi: voto 8