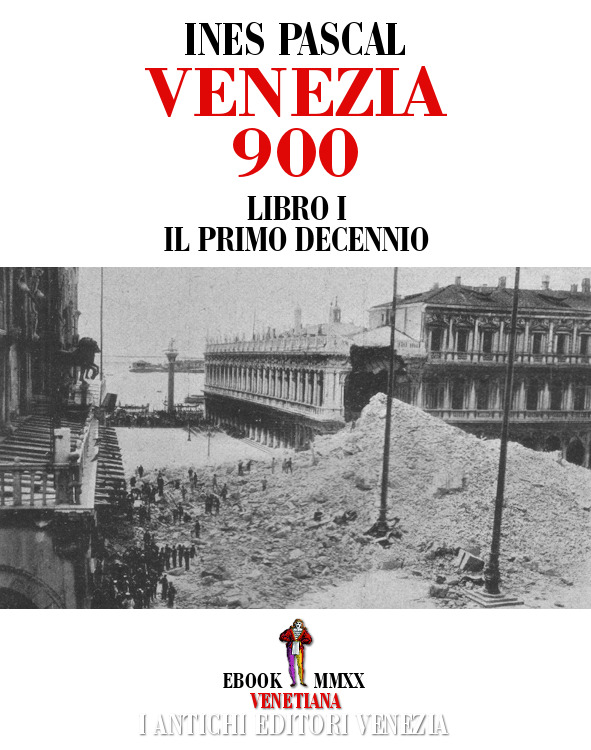Prima o poi
giocherò con te
Correva l’anno 1955 quando la mia famiglia si trasferì dal centro storico di Venezia all’isola del Lido. Fino a un secolo prima, il Lido era solamente una striscia di sabbia lunga dodici chilometri, che divideva la laguna dal mare Adriatico. L’attività prevalente era l’agricoltura. Ma qualcosa di speciale doveva comunque avere, il Lido, in quanto personaggi come Lord Byron, Alfred De Musset, George Sand e altri scrittori, artisti e poeti, spesso si rifugiavano lì a cercare l’ispirazione per le loro opere.
Fu a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo che la scoperta dei bagni di mare e delle proprietà terapeutiche del clima marino, la vicinanza di Venezia e la bellezza della spiaggia di sabbia finissima, fecero del Lido una stazione balneare e un centro di mondanità cosmopolita. Negli anni a seguire furono costruite numerose ville in stile liberty, la cui bellezza si può ammirare tutt’oggi.
Si arrivo’ così all’inizio del Novecento, quando la Ciga, la Compagnia Italiana Grandi Alberghi, credette nelle enormi potenzialità turistiche del Lido, e costruì il Grand Hotel Des Bains, da subito frequentato dalla nobiltà internazionale, che ispirò il celebre scrittore Thomas Mann, Premio Nobel per la letteratura nel 1929 e assiduo ospite dell’albergo, a scrivere «La morte a Venezia» ambientato proprio in questo albergo, da cui venne tratto il film omonimo del regista Luchino Visconti.
Dopo otto anni la Ciga inauguro’ un altro hotel di lusso, l’Excelsior, in perfetto stile orientale e, a seguire, furono costruiti il Palazzo del Cinema, che vide nel 1932 la prima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e il Casino’ che, ogni anno per sei mesi, si trasferiva da palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sul Canal Grande, al Lido. Fu grazie a tutto ciò che il Lido di Venezia divenne famoso in tutto il mondo e, in quegli anni, si merito’ il soprannome di «Isola d’ Oro”.
Ma, in realtà, la casa che si costruirono i miei genitori aveva poco a vedere con le ville liberty e con l’isola d’oro: era una piccola palazzina in mezzo a dei terreni dove coltivavano carciofi, distante circa cinque chilometri dal centro, che in considerazione dei mezzi di trasporto a disposizione in quel tempo, sembrava fosse in capo al mondo: infatti la zona con noi confinante si chiamava «Terre Perse».
Quando si arrivava al Lido da Venezia c’erano due possibilità per raggiungere quel piccolo quartiere dove abitavamo: o la «filovia», che passava ogni ora, oppure la più affascinante, ma di gran lunga più lenta carrozza a cavallo. C’erano sette o otto case sparse qua e la’ con un’unica bottega di alimentari, «Ciano Luganegher», così si chiamava e si chiama tuttora quel negozietto che è riuscito a sopravvivere all’invasione e alla concorrenza dei supermercati grazie alle sue prelibatezze! Ricordo che non c’era ancora la chiesa, e le funzioni, messa compresa, avevano luogo all’interno di un bunker abbandonato dopo la prima guerra mondiale.
Quando ci trasferimmo al Lido, io ero ancora piccolo. Ricordo però che i miei scherzavano su come potevano chiamarsi gli abitanti del Lido, e mia madre diceva a mio padre: «pensa, Rino, se ci chiamano «lidioti!». E scoppiavano a ridere. Ma da li’ a poco, con grande sollievo, scoprirono che gli abitanti del Lido venivano invece chiamati «lidensi». Ci trasferimmo in quest’isola per motivi di lavoro di mio padre, che aveva un’ impresa edile e si era aggiudicato l’appalto per l’ampliamento e la manutenzione dell’ospedale: lavori che sarebbero durati parecchi anni.
La nostra casa aveva un grande giardino, che non avevo mai visto nelle case di Venezia, e ricordo che mio padre diceva a me e a mio fratello: «in questo giardino possiamo anche giocare a pallone…». A mio fratello Franco, in verità, poco interessava giocare a pallone, era tutto preso a leggere fumetti, da Capitan Miki al Grande Blek, all’Intrepido»…Questo era il suo mondo. A me invece piaceva tantissimo giocare a pallone! Eravamo una decina di compagni di scuola: appena finito di pranzare ci trovavamo in un campetto, dove qualche anno più tardi sarebbe sorta la chiesa, quella vera…Questo campetto era proprio davanti a casa mia.
Mio padre era molto occupato con il suo lavoro, aveva sei bocche da sfamare (io e mio fratello, due sorelle gemelle più piccole, lui stesso e mia madre, la quale, naturalmente, non poteva lavorare con una famiglia così numerosa da accudire), per cui tempo per giocare con noi non ne aveva…»Papa’, oggi vieni a giocare a pallone con me in giardino? -gli chiedevo quasi quotidianamente — e la risposta era sempre la stessa: «Marino, oggi sono stanco, ma uno di questi giorni facciamo una partita «uno contro uno». Io abbassavo il capo e annuivo…ma molto malinconicamente. Però ricordo ancora la felicità che provavo, mentre stavo facendo la quotidiana «partitella» con i miei compagni, quando riuscivo a scorgere la sua figura dietro alle tende della finestra di casa, che, senza farsi vedere, mi guardava giocare. Prima di tornarsene al lavoro passava per il campetto, mi dava un bacio e in un orecchio mi sussurrava: «bravo! Hai giocato bene», e mentre se ne stava andando si voltava e mi diceva: «stai attento a non sudare troppo, e respira con il naso!» E così contento, riprendevo a giocare.
Era la primavera del 1958. Ricordo ancora il mio giardino ricoperto da bellissime margherite. Per non calpestarle giocavo lungo il vialetto in cemento che divideva il giardino, in attesa che arrivasse l’ora per raggiungere il campetto e i miei compagni. All’improvviso sentii una voce che mi chiamava: «Marino!». Mi girai e vidi don Gino, il cappellano che celebrava le messe nel bunker, che appoggiando la bicicletta al muretto mi chiese: «Siete tutti in casa?» «Si — risposi — abbiamo appena finito di pranzare».»Accompagnami da tuo padre, bisogna far presto!”.
Scesi le scale di corsa seguito dal prete, spalancai la porta e dissi: «C’è don Gino!». Mio padre era spaparanzato sul divano, la cinghia dei pantaloni allentata e Il Gazzettino tra le mani, mia madre stava lavando i piatti canticchiando una canzone napoletana che a lei piaceva tanto, mio fratello stava leggendo l’ultimo numero dell’ Intrepido e le mie sorelline stavano bisticciando tra loro. Alla vista del cappellano ammutolirono tutti. E si ricomposero. «Preparatevi che tra dieci minuti arriva il Patriarca che vi vuole conoscere», disse don Gino tutto affannato. «Ma dove, e perché proprio noi?», chiese stupito mio padre. «Vuole conoscere una famiglia bella e numerosa, e ho subito pensato a voi. Così ora sta arrivando qui, proprio in casa vostra!”. «Qui…in casa nostra…e tra dieci minuti?» chiese esterrefatto mio padre. » Beh si…non potevo mica farlo venire nel bunker!», rispose don Gino come se fosse tutto ovvio. «Gli vado incontro…ah, sia lodato Gesu’ Cristo». E noi in coro: «sempre sia lodato». Dopodiché ricordo un gran daffare per rigovernare la casa da parte di mia mamma, e mio padre che ci disse: «scendete in giardino, aspettate lì e ricordatevi, quando passa il Patriarca, inginocchiatevi, e se vi porge la mano, baciategli l’anello».
Naturalmente noi non sapevamo chi e che cosa fosse un Patriarca, ma capimmo subito che doveva trattarsi di una persona molto importante. Poco dopo infatti si fermo’ davanti a casa un’elegante auto nera, una Lancia Appia. Dalla porta anteriore, a lato dell’autista, scese don Gino, da quella posteriore un altro prete, e insieme andarono ad aprire l’altra porta da cui si affacciò un uomo anziano, robusto, il viso pacioccone e un gran nasone. Indossava un abito da prete, ma con una mantellina rosso porpora sopra alla veste, e in testa aveva un cappello circolare dello stesso colore del mantello.
Quando passo’ lungo il vialetto, noi eravamo già inginocchiati, e con lo sguardo teso verso di lui, pronti a baciare l’anello appena ci avesse porto la mano. Ma quando il Patriarca entro’ in giardino e ci vide tutti e quattro schierati inginocchiati, si fermo’ e disse: «ma cosa fanno tutti questi bei bambini inginocchiati? Su, su, alzatevi che voglio vedere quanto siete alti». Noi obbedimmo, e appena alzati ricevemmo buffetti sulle guance in abbondanza. Poi si avvicino’ a me, mi fece una carezza, e appoggio’ la mia testa sulla sua immensa pancia. Quella carezza mi trasmise qualcosa di speciale, una sensazione di pace e felicità che ricordo ancora adesso. Nel frattempo erano scesi i miei genitori che gli si avvicinarono e, inginocchiandosi, gli baciarono l’anello.
Dopo essere saliti tutti in casa, ci accomodammo in salotto: il Patriarca su una poltrona tutta ornata con merletti di Burano, i due prelati sul divano, una poltrona rimase libera, per rispetto, e noi sei ci sedemmo su due sedie, noi bambini sulle gambe dei nostri genitori. Mentre il Patriarca faceva alcune domande ai miei, io lo guardavo…quanto era grosso! E poi guardavo don Gino, e l’altro prete…quanto erano magri!…Così pensavo: «a fare il Patriarca si mangia molto di più che a fare il prete….vuol dire che da grande farò il Patriarca!».
Ma io oramai cominciavo a scalpitare, perché sentivo le voci dei miei amici che erano già arrivati nel campetto, pronti per iniziare la partita. Quando improvvisamente il Patriarca disse: «ora ascoltatemi bene, che devo darvi una bella notizia: davanti a casa vostra, sorgerà la nuova chiesa, con la nuova parrocchia!»
Fui assalito subito da un terribile sospetto. E a quel punto, senza indugiare, chiesi: «ma…davanti dove?». Don Gino disse lesto: «dove ora c’è il campetto». E io subito «ma…allora, non potremo più giocare a pallone?». A quel punto intervenne il Patriarca : «Il Signore e’ felice quando i bambini si divertono, e sicuramente non vi lascerà senza campetto…don Gino ve ne preparerà uno più bello e più grande». Io replicai timidamente: «…ma il mio papà’ non mi potrà più veder giocare dalla finestra…» E il Patriarca, pronto: «ho visto che avete un bel giardino grande, dove puoi giocare con i tuoi compagni, lì tuo papà potrà vedervi».
Io non mi arresi: «ma ci sono le margherite e non possiamo calpestarle…e poi in giardino devo giocare a pallone con il mio papà…” Il Patriarca trovò una soluzione: «allora faremo in modo che il nuovo campetto abbia delle panchine dove i papà possano sedersi a guardare i propri bambini che giocano…e lei deve andarci!”, disse rivolto a mio padre sorridendo, ma con un tono austero. «E poi -aggiunse perentorio- giochi in giardino con suo figlio, eh!”. “E tu — proseguì rivolto a me — non ti devi preoccupare per le margherite, che tanto ricrescono! Pero’ mi devi promettere che farai il chierichietto, perché don Gino ha bisogno di bravi bambini come te».
Quindi ci abbraccio’ tutti e ci diede la benedizione. Nel maggio seguente lo incontrai nella parrocchia vicina dove mi cresimo’. Nel mese di settembre dello stesso anno ritorno’ nel nostro quartiere per la posa della prima pietra della nuova chiesa, e io servii messa per la prima volta. Finita la celebrazione, si avvicino’ e sottovoce mi chiese: «il tuo papà ha giocato a pallone con te?». Feci segno di no, imbarazzato, abbassando la testa. «Beh, se tuo papà, che ti vuole tanto bene, non è venuto a giocare con te, vuol dire che ha molte cose importanti, sicuramente più importanti da fare. Ma abbi pazienza, vedrai che prima o poi lo farà».
Quella fu l’ultima volta che lo vidi, il Patriarca. A ottobre andò a Roma per il conclave e il 28 ottobre 1958 fu eletto Papa. Il nostro Patriarca Giuseppe Angelo Roncalli assunse il nome di Giovanni XXIII. Il 27 aprile 2014 è stato proclamato Santo. San Giovanni XXIII, il «Papa buono».
Da alcuni anni ho lasciato il Lido di Venezia, ora vivo all’isola d’Elba. Qui, l’anno scorso, hanno ripulito e spianato un terreno vicino a casa mia. Sembrava proprio un campo di calcio, come quello della mia infanzia. Ero alla finestra. A un certo punto ho chiuso gli occhi, e ho «visto» apparire, dal fondo del campo, il Patriarca Angelo Roncalli che teneva per mano mio papà, e il mio papà teneva sottobraccio un pallone da calcio, di cuoio scuro, come si usava una volta. Poi l’immagine del Patriarca svanì. E rimase quella di mio padre, che mi lanciava il pallone e mi diceva: «dai, Marino, vieni che giochiamo…ma attento a non sudare troppo..e respira con il naso».