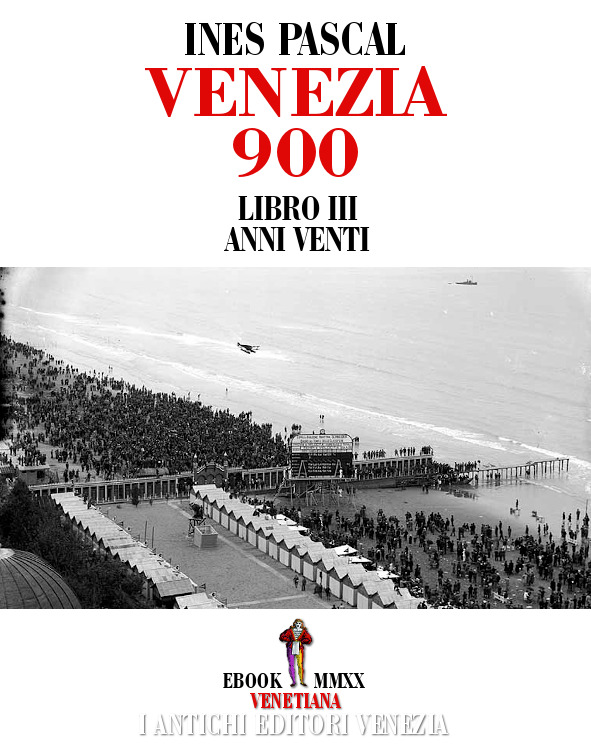Il giorno che Nando
tornò a Veneland
Nando aveva una camicia auaiana. Bellissima. Tutta fiori e palmizi, mari e tramonti, spiagge e mulatte, banane e maracas. Era l’unico ad avere una camicia così nella Venezia degli anni cinquanta, e per strada lo guardavano tutti. Quasi tutti. Lui ne era orgoglioso. Panama, occhiali neri, sigaro avana, camicia auaiana appunto, bermuda e mocassini bianchi, sembrava un turista americano. «Mericàn», i lo ciamava i baristi del bar della piazza, quello all’angolo, sotto la torre dell’orologio, dove andava ogni giorno a guardare le donne e ciavarse l’americano. A quel tempo a Venezia i turisti erano rari, e a lui piaceva travestirsi da turista. Non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbero stati i turisti a travestirsi da veneziani e a prendere il loro posto.
Nando che pasteggiava a gionniuocher etichetta rossa e regalava sogni proibiti alle antrenès dei naitclebs pensava a questo guardando fuori dal finestrino del treno che lo riportava a Venezia dopo tanti anni. Di là del vetro pioveva una nebbiolina sottile, un calìgo insinuante che si divertiva a nascondere i contorni delle cose. L’acqua della laguna, intorno al ponte della libertà, aveva il colore della carta stagnola dei presepi. Sembrava finta. Lui si sentiva un po’ stanco. Aveva fatto un lungo viaggio per tornare a ritrovare, dopo una vita sventolata altrove, i luoghi della sua infanzia. In aereo da Città del Messico, dove adesso viveva, a Parigi, e da Parigi a Venezia in treno, perché si ricordava quel viaggio fatto da ragazzo, e voleva ritrovarne i sapori sui binari. Non ne ritrovò nessuno.
Un gran brusio, come un tumulto, spezzò il filo dei suoi ricordi all’improvviso. La carrozza di prima classe, dove stava spaparanzato, le gambe allungate, pochi viaggiatori distratti, tutti con delle cuffiette nelle orecchie, venne travolta da una carica di bufali. Era un gruppetto di una ventina di ragazzi, molto giovani, in maschera. Avevano dei costumi di Carnevale. Arlecchini, Pantaloni, Pierrots e Colombine. Gli sembrò di intravedere anche dei Pulcinelli e qualche Balanzone. Correvano, saltavano, si spingevano. Gridavano, ridevano, starnazzavano, suonavano trombette dalle lunghe lingue e lanciavano manciate di coriandoli. Una Colombina con gli occhi a mandarino, la gonna a fiori e uno scialle di lana traforata sulle spalle, gli passò accanto veloce come un colpo di frusta e gli lanciò un biglietto colorato. Lui l’afferrò al volo e sentì il suo profumo. Sapeva di zucchero e di miele. Non fece in tempo a guardarle il culo. La carica dei bufali mascherati passò svelta come un tornado, diretta alla carrozza successiva, lasciandosi dietro una scia di stelle filanti.
Nando aprì quel biglietto. Era un depliant. «Benvenuti a Veneland», c’era scritto. A lettere gialle fosforescenti. Era una mappa della città su cui erano segnati, cerchiati in rosso, i punti di maggior interesse turistico. Chiese, musei, monumenti, calli, ponti, pontili, cessi, casini, fastfud e mecdonal. Nando diede un’occhiata distratta alla mappa, la piegò e se la mise in tasca. Primo perché non aveva gli occhiali e gli seccava tirarli fuori. Secondo, perché la città la conosceva benissimo. Mica avranno spostato il ponte di Rialto. Però si sorprese del parco di divertimenti. Veneland non poteva voler dire altro. Non sapeva che ne avessero costruito uno. Beh, però è passato tanto tempo. Chissà dove l’avranno messo, pensò. Forse al Lido, probabile, lì c’era spazio, magari nel vecchio aeroporto, o agli Alberoni. Oppure al Tronchetto. Difatti non vide più la cupola del tendone del palafenice, si ricordava di aver letto che avevano spostato lì il teatro quando la Fenice era bruciata. Ma forse era colpa del calìgo se non lo vedeva. Eh no accidenti, adesso si accorse che il calìgo non c’era più. La nebbiolina era svanita come per incanto ed era spuntato il sole. Ma al Tronchetto vide solo giganteschi garage e minuscoli trenini a rotaia che correvano a cinque metri d’altezza e sembravano sospesi nell’aria. Niente parchi né tendoni.
Alla stazione di Santa Lucia, chissà se si chiamava ancora così, non c’era scritto da nessuna parte, il treno si svuotò. Nando notò, dalla folla di passeggeri che scendeva, che le altre carrozze dovevano essere state tutte piene. E che tutti sembravano avere una gran fretta. Difatti correvano verso l’uscita spintonando. Cercando di superarsi. Molti avevano borse e valigie ingombranti. Erano di tutte le età, e la maggior parte sembravano stranieri. Turisti, evidentemente, pensò. Lui non aveva fretta. Non ne aveva alcun motivo. Scese per ultimo e si fermò sulla pensilina. Si ricordava che ogni volta che tornava a Venezia, appena metteva piede giù dal treno, sentiva subito, prepotente, quell’odore salmastro dell’aria della laguna che gli pizzicava il naso e gli ricordava l’isola dov’era nato. Non sentì più nessun odore. Forse è perché sono raffreddato, si disse, prese un fazzoletto di carta della tasca sinistra dei pantaloni e si soffiò il naso guardando cosa aveva soffiato. Fece una smorfia. Ma era contento. Sono tornato a casa.
La stazione assomigliava a quella che lui si ricordava. Ma non gli ci volle molto, appena uno sguardo più attento, per notare che qualcosa era cambiato. Dalla parte dell’uscita, l’edificio principale sembrava un castello. Aveva i merli, le arcate e i torrioni, persino i ponti levatoi. Notò che erano di plastica. Davanti al castello c’erano dei botteghini dove la gente scesa dai treni faceva la fila. Realizzò con un’occhiata che non c’erano altri varchi e si mise pazientemente in fila anche lui. Non aveva fretta, l’ho già scritto. Vide che la gente che stava in coda, e sembrava molto eccitata, alcune signore saltellavano lanciando gridolini, comperava dei biglietti. Comodo, pensò. Avranno spostato qui le biglietterie dei vaporetti. Quando arrivò il suo turno, dopo una venticinquina di minuti, una signorina molto gentile dagli occhi molto bistrati che vestiva un curioso abitino rosso porpora che si sarebbe potuto dire del settecento, gli diede in cambio dei soldi un biglietto grande come un lenzuolo, tutto colorato, e gli spiegò, in un perfetto inglese di Maerne –lui per gentilezza non la interruppe, lo capiva abbastanza – che con quel biglietto poteva scorrazzare giorno e notte per tutta la città con tutti i vaporetti, entrare a gratis nei musei, ottenere uno sconto del dieci per cento in una serie di alberghi, ristoranti e negozi (sul retro del biglietto c’era l’elenco), del cinque per cento per un giro in gondoleta con cantante napoletano incluso, e per di più avere un posto riservato allo spettacolo della sera sulla storia di Venezia, anche questo in inglese, con attori in maschera, proiezioni multimediali, musici, cantori, ombre e cicheti e sonelumier. Caspita. Come si sono evoluti, pensò. E ben organizzati. Ai miei tempi non c’era niente di tutto questo. Al massimo, quando arrivavi, trovavi ad accoglierti degli omaccioni con tanti anelli e grandi collane d’oro, camicia aperta sul petto al quinto bottone, che ti portavano dove volevano loro, gondole, taxi, alberghi, ristoranti e vetrerie, ti facevano comperare delle meravigliose quanto inutili paccottiglie spacciandotele per artigianato locale, e alla fine ti spellavano come si conviene.
Superato il varco delle biglietterie, la fila dei viaggiatori si andava a imbottigliare in un unico budello stretto fra due righe di transenne metalliche colorate di rosso carminio e foderate di ermellino con tante lampadine colorate accese intorno. In fondo al budello, da dove arrivava una strana musica registrata che usciva da un grumo di altoparlanti appesi al soffitto, si sarebbe potuto dire qualcosa che assomigliava a Vivaldi micsato a ritmo discomiusic, c’era un tornello foderato in pelle di capretto da cui bisognava passare. Appollaiato su uno sgabellino accanto al tornello c’era un uomo con una divisa da maggiordomo di altri tempi. Aveva una giacca blu lisa sui gomiti con metà dei bottoni dorati – Nando notò che gli mancava quello del colletto – al quale dovevi mostrare il biglietto per poter passare. L’uomo non sorrideva. Anzi il suo viso era atteggiato a una smorfia perenne. Era anziano, molto magro, si vedeva dal collo che gli ballava nella camicia un po’ unta. Aveva il volto scavato, solcato da una tempesta di rughe, e una barba candida e lunghissima. Quell’uomo tristissimo gli ricordava qualcuno ma non ricordava chi.
Quando uscì sul piazzale della stazione, la città gli sembrò finalmente uguale a come se la ricordava. Il ponte degli Scalzi ancora al suo posto, la chiesa, il cupolone verdastro stinto di San Simeon, e là davanti il Canal Grande con i vaporetti, le barche, le gondole, i bar sulle fondamente, la calca angosciante dei turisti.
Quello che non capiva è perché ci fosse tanta gente in maschera. Come a Carnevale. Ma non era Carnevale. Si ricordava che Carnevale capitava in febbraio. Al massimo in gennaio, se arrivava presto, o al più tardi in marzo, se veniva tardi. Ma adesso era dicembre. Non era neanche Natale. Com’era possibile? La spiegazione, a questa domanda non detta, solo pensata, gliela diede un grosso displei a cristalli liquidi che giganteggiava in varie lingue davanti alla fermata del vaporetto dove stava per andare. «Benvenuti a Veneland – c’era scritto – dove il Carnevale dura tutto l’anno». Seguiva un elenco, lunghissimo, degli spettacoli che andavano in scena quel giorno nei campi, nei teatri, nelle chiese e nei palazzi. Però, si disse Nando, ammirato, ricordandosi che ai suoi tempi quella del Carnevale perenne era solo una battuta di un comico di Murano che lo faceva tanto ridere. Toffolo, si ricordò, sì, Toffolo.
Al pontile del vaporetto chiese a un giovanottone vestito da Arlecchino, che portava sul costume una targhetta plastificata di riconoscimento con un numero, un nome, un timbro e una foto, presumibilmente la sua, anche se sembrava di qualche anno più giovane, quale linea doveva prendere per andare a Rialto. Non se lo ricordava più. Fu a questo punto, mentre l’Arlecchino gli stava rispondendo con una sfilza di numeri, erano quelli dei battelli, che si accorse che stava sudando e si levò il cappotto di cammello.
«Come mai fa così caldo in dicembre?».
Il bigliettaio, perché questo era il lavoro dell’Arlecchino che controllava i biglietti ai passeggeri, si voltò verso un altro displei alle sue spalle, più piccolo del primo, e controllò la temperatura che c’era scritta: venti gradi.
«Ma no, signore – gli disse – la temperatura è quella giusta. Venti gradi. Come sempre».
«Come, come sempre?».
«Come, non lo sa? Qui a Veneland i condizionatori tengono la temperatura sempre costante. Venti gradi estate e inverno. Così i visitatori non soffrono né per il caldo né per il freddo, e possono andarsene in giro tranquillamente a godersi la città, a vedere gli spettacoli nei campi, sostare nei bar, e cenare sempre all’aperto».
«Ma come fate a mantenere costante la temperatura anche all’aperto?».
«La cupola, monsieur».
«Come la cupola? Quale cupola?».
«È l’effetto della cupola di plexigas che avvolge tutta la città e la protegge. Non l’ha vista? Ma no, che sciocco, è ovvio che non l’ha vista. Non la può vedere. È perfettamente trasparente. Come se non ci fosse».
«Vuol dire che Venezia è chiusa dentro una palla di vetro?».
«Esattamente, monsieur. Ma questa è Veneland, non è Venezia. Venezia non esiste più. E la palla, come la chiama lei, è di plexigas, non di vetro».
«Non mi chiami monsieur. Non sono francese».
«Va bene mister».
«Non sono neanche inglese».
«Neanch’io».
«Meglio così. È argentino? Ha un accento sudamericano».
«Venezuelano».
«Beh, almeno qualcosa ci azzecca. Ma mi dica: allora vuol dire che qui non piove mai?».
«Mai».
«E non vengono neanche le nuvole? Né il vento? Né la nebbia? Neanche un po’ di calìgo?».
«Niente di niente. Qui c’è sempre il sole, come vede».
«E come fate a far venire il sole?».
«È artificiale, naturalmente. Come anche il cielo sopra di noi. Sono effetti luminosi governati dal grande compiuter. Fanno arrivare a comando anche la notte e la luna, e di notte il cielo è sempre stellato».
«E come diavolo si respira? Da dove entra l’aria?».
«Ci pensano i condizionatori. Sono installati sui tetti della case e dei palazzi, accanto ai comignoli, in modo che non si vedano e non turbino l’estetica. Sono molto potenti. Fanno venire l’aria fresca d’estate e calda d’inverno».
«Mai vista una città ad aria condizionata».
«Si sta che è una bellezza. L’apprezzerà anche lei, vedrà. Le auguro un piacevole soggiorno, herr…».
«Non sono tedesco».
«Mi scusi, caballero».
«Fa niente. Grazie comunque».
«Dovere».
Nando era stupito. E perplesso. Molto perplesso. Tutto si sarebbe aspettato. Ma questo no.
Con un passo incerto entrò nel pontile. Lasciò passare un vaporetto, che era stracarico, zeppo di maschere urlanti, e rimase all’aperto, tanto faceva caldo, ad aspettare il prossimo. Guardava l’acqua del canale. I riflessi del sole sull’acqua facevano una ragnatela di raggi d’argento che gli ballavano negli occhi. Non riusciva a vedere bene. Fu solo quando arrivò il vaporetto, da cui scese una scolaresca che cantava a squarciagola, che si accorse che l’acqua non c’era più.
Al posto dell’acqua c’era un gigantesco lenzuolo di nailon color verde acquamarina che si agitava imitando il movimento delle onde, e veniva mosso da alcuni possenti ventilatori che individuò fissati sotto le rive del canale. I vaporetti, in tutto e per tutto uguali, salvo le megascritte pubblicitarie, a quelli della sua infanzia, correvano su una monorotaia che attraversava in un senso e nell’altro il canale asfaltato.
«L’acqua l’hanno tolta – gli spiegò l’Arlecchino che era venuto a far finta di prendere la corda che gli lanciava il marinaio per fingere di far attraccare il vaporetto al pontile – perché ormai era marcia, puzzava, portava in giro solo rifiuti, poi ogni tanto il canale andava in secca impedendo la navigazione, e ogni tanto arrivava l’acqua granda che provocava alluvioni, guasti e disagi. In un caso e nell’altro, insomma, c’erano sempre problemi. Così è molto meglio. Più pratico e più igienico».
«Sarà. Io preferivo l’acqua».
«È il progresso, monsieur. Non si può fermare il progresso. Specialmente quando il progresso porta vantaggi e benefici».
«Ma va in mona!», si lasciò scappare Nando, ritrovando come per incanto, da chissà quale anfratto della sua memoria, l’antico idioma natio. L’Arlecchino bigliettaio gli rispose con un sorriso che a lui sembrò falsissimo.
Sul vaporetto monorotaia che percorreva il Canal Grande asfaltato fino a Rialto, Nando si sedette a poppa e guardò fuori. Più spaesato che curioso. Più spaventato che contento. Quasi inorridito. Terrorizzato addirittura. La vista delle case e dei palazzi, che grosso modo ricordava, lo tranquillizzò. Quelli almeno erano rimasti tutti al loro posto. Le scritte, no. Quelle scritte, gli pareva, non c’erano. Scritte al neon. Colorate. Di ogni tipo e dimensione. Scritte. Scritte. Scritte in tutte le lingue del mondo. Scritte ovunque. Alberghi da una a ventisette stelle lusso ed estralusso, pensioni, locande, ostelli, bedenbrecfast, residens, affittacamere, appartamenti, suit arredate coi mobili originali del quattrocento, del cinquecento, del seicento, del settecento, la maggior parte, e dell’ottocento. E poi ristoranti, trattorie, taverne, osterie, bar, fastfud, selfservis, mense del turista e dello studente, cenacoli del viaggiatore e del pellegrino, e negozi di tutte le firme possibili e impossibili, e locali per tutti i gusti e per tutte le tasche, teatri di lirica, di prosa, di varietà e di striptis, discoteche, densing, naitclebs, discobar, discopab, cabarè e tabaren, e insegne luminose rosso fuoco con ammiccanti siluet di donnine scosciate e calici di sciampagn, e case da gioco e casinò e casini del piacere e fumerie d’erbe e di oppio. Nando restò scioccato. Non credeva ai suoi occhi. Non ci poteva credere. Non ci voleva credere. Nei lunghi anni vissuti all’estero doveva essersi perso qualche puntata. Cos’era successo alla sua città?
Lo chiese al suo vicino di posto. Era un signore anziano. Più anziano di lui. Aveva una giacca rossa e un paio di pantaloni dello stesso colore corti al ginocchio, si sarebbe detto un vestito del settecento. Portava una camicia bianca con dei giabò e una spilla dorata, una specie di cammeo, appuntata al centro del collo. In testa aveva una parrucca di boccoli candidi e un tricorno nero con delle lampadine colorate tutto intorno che ogni tanto accendeva pigiando un bottone del gilet damascato. Sembrava un cicisbeo. Era leggermente incipriato e starnutiva come una bestia dando la colpa a «questa maledetta aria condizionata».
«Venezia non esiste più, caro signore – gli rispose il cicisbeo soffiandosi il naso dentro un guanto bianco – al suo posto oggi c’è Veneland, il più grande parco storico di divertimenti del mondo. Dev’essere da tanto che lei non viene più in città, vero?»
«Sì, è così. Ma cos’è successo qui? E quando?».
«Oh, è successo già da una decina d’anni, mi pare, non ricordo più bene. Ormai non c’erano più abitanti. O, per meglio dire, ne erano rimasti pochissimi. E non c’era più un’industria, più nessuna attività economica. Non c’era più lavoro. E non essendoci praticamente più abitanti avevano chiuso, una dopo l’altra, tutte le botteghe che scandivano la vita normale di tutti i giorni, dai panettieri ai macellai, dai fruttivendoli alle merciaie. Erano rimasti solo i turisti. Tantissimi. Decine di milioni. L’unica industria che ancora funzionava. E rendeva. Così non è rimasto altro da fare che trasformare tutta la città in un enorme parco di divertimenti e far pagare un biglietto per entrare come si fa a Disneiland e a Gardaland… eccì!».
«Salute».
«Grazie».
«Prego. Ma mi dica: e… e gli ultimi veneziani rimasti? Perché lei è veneziano, no?».
«Sì, anche se ormai non me ne ricordo quasi più. Noi ultimi veneziani rimasti siamo stati assunti dal nuovo padrone, che è una società americana. Ci trattano bene. E ci pagano, anche».
«Vi danno uno stipendio per fare le maschere?».
«Per fare i veneziani. In maschera».
«E le altre maschere?».
«Tutti immigrati. Molti clandestini. Del resto a Venezia non ci sono sempre stati i mori? Ah, ah! Tutti impiegati, anche loro. È già stato all’Arsenale?».
Nando era distrutto. Nel suo cuore si era aperta una ferita larga come il Mississipì e nelle tempie sentiva un martello che batteva furioso.
«No».
«Ci vada, ci vada. Oggi pomeriggio alle tre ricostruiscono la battaglia della flotta veneziana contro i Tartari Ugri. È uno spettacolo bellissimo, sembra vero, se si sbriga farà in tempo, e non le costerà nulla, l’ingresso è compreso nel prezzo del biglietto che ha già comprato».
Nando non trovò da nessuna parte la forza di rispondergli. Il vaporetto stava arrivando alla fermata di Rialto. La folla che si spintonava nella parte aperta del battello gridò. Di ammirazione, non di paura. Un gruppo di una dozzina di acrobati fasciati in attillatissimi costumi color oro, paonazzo e cremesin, si stava calando dal ponte di Rialto appeso a delle corde sottili di seta bianca intrecciata. Nando guardò meglio. Dopo qualche minuto di attenta osservazione si accorse che c’era qualcosa di strano. Gli acrobati adesso stavano appesi proprio sopra il tetto del battello. Dai movimenti, che apparivano lenti e un po’ legati, sembravano dei manichini.
«Manichini», sibilò Nando.
«Certo, manichini – fece il vecchio cicisbeo – far esibire dei veri acrobati ad ogni passaggio di un vaporetto sotto al ponte sarebbe troppo pericoloso, oltre che costoso per l’ingaggio e faticoso per gli stessi acrobati. Meglio i manichini. Non si rischia nulla, e costano soltanto un po’ di manutenzione ogni tanto, quando si arrugginiscono gli ingranaggi. Del resto – aggiunse soffiandosi un’altra volta il naso – ormai i manichini li hanno messi quasi dappertutto. Finirà che sostituiranno anche noi».
«Davvero?».
«È così. Anche il pilota che guida questo vaporetto è finto, non se n’era accorto? È un manichino anche lui. Il vaporetto del resto corre sempre sulla rotaia, ed è programmato dal computer per fermarsi ad ogni pontile. Il pilota non serve più».
«E quelle belle ragazze vestite da cortigiane che ho visto affacciarsi con le tette fuori dai balconi? Non mi dica che sono finte anche quelle!».
«Certo. Anche loro sono manichini. Fatte bene, questo sì, ma manichini. Come i crupiè dei casinò e gli attori dei cabarè. Ormai è tutto robotizzato. Automatizzato. Si risparmia sui costi, la resa è sicura, e non ci sono mai scioperi».
«Mi sa che di questo passo faranno finti anche i piccioni…», mormorò Nando a voce bassissima, la testa china. Ormai era in preda allo sconforto più cupo e alla depressione più profonda.
«Indovinato!», battè le mani il cicisbeo, uno sbuffo di cipria solleticò Nando alle narici.
«Eccì!».
«Salute».
«Che cosa ha detto?».
Nando impallidì soffiandosi a sua volta il naso.
«Ho detto che quello che lei ha appena detto l’hanno già fatto».
«Sta scherzando».
«Nemmeno per sogno. Non ce n’erano più di piccioni. Scomparsi anche loro, proprio come gli abitanti. Da quando avevano deciso di non dar più loro da mangiare se n’erano andati altrove. Volati via, in altre città, in cerca di cibo. Ma i turisti li volevano. Con chi avrebbero fatto le foto ricordo? Così li hanno sostituiti con degli uccelli meccanici. Imitazioni perfette. Volano a motore, alimentati da pile ecologiche, e sono del tutto identici ai piccioni veri. Impossibile distinguerli a occhio nudo. In più non sporcano, non portano malattie, non rovinano i monumenti, e non c’è alcun bisogno di dar loro da mangiare. Geniale, non trova?».
Nando non rispose neanche stavolta. Il vaporetto aveva ormai attraccato alla fermata.
«Lei non scende?», gli chiese, alzandosi, il vecchio cicisbeo.
«No, no, grazie…», rispose Nando, incerto, imbarazzato. Per lui era troppo. Davvero troppo.
Si alzò, uscì dalla cabina e andò dal marinaio che stava guardando la gente che scendeva.
«Torna indietro questo vaporetto?».
«Vaporetto torna indietro – cric – vaporetto torna indietro – cric – vaporetto torna indietro – cric–», rispose per tre volte, con una voce metallica, il marinaio. Solo allora Nando si accorse che era un robot. Mentre parlava gli occhi lampeggiavano e i bottoni della sua giacca blu si accendevano e si spegnevano a una cadenza regolare.
«Bene. Allora torno indietro anch’io», disse Nando, ritornando a sedersi. Il marinaio non gli rispose. Adesso gli lampeggiavano le orecchie.
Nando fece tutto il viaggio di ritorno senza guardare più fuori. Se ne stava mesto, la testa fra le mani, assorto nei suoi pensieri. Una comitiva di spagnoli che era salita sul vaporetto cantava Guantanamera. Giunto alla stazione salì sul primo treno che partiva senza chiedere dove andava. Davanti al tornello c’era ancora lo stesso uomo anziano, molto magro, il volto scavato, solcato da mille rughe, la barba candida, lunghissima, che aveva visto al suo arrivo. Quell’uomo che gli ricordava qualcuno ma non riusciva a ricordare chi. Gli sembrò che in qualche modo gli sorridesse. Ma quel sorriso tristissimo più che a un sorriso assomigliava a un ghigno.
(tratto dall’antologia di Roberto Bianchin «Non ricordo più nulla» I Antichi Editori Venezia)