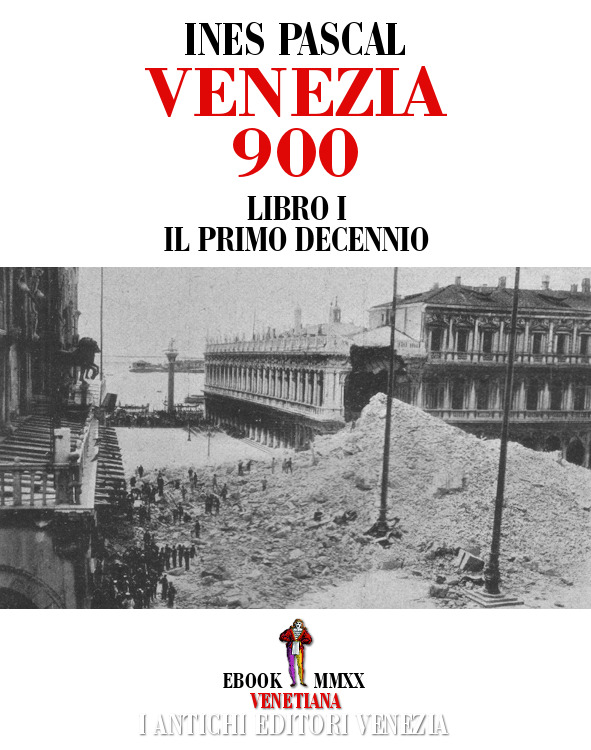1455: Alvise Da Mosto
sfida l’Atlantico
Il viaggio del navigatore veneziano che arrivò in Senegal e scoprì le Isole di Capo Verde
Navigatori si nasce, specialmente nella Venezia della prima metà del quattrocento. Altrimenti lo si diventa. Poco più di vent’anni, una situazione economica familiare difficile, la volontà di provvedere al mantenimento della propria posizione sociale inducono i fratelli Da Mosto, Alvise e Giovanni, a imbarcarsi con un carico di sete diretti verso i mercati delle Fiandre alla guida di una nave della flotta del Barbarigo.
Oltre lo stretto di Gibilterra sono costretti, da correnti contrarie e venti sfavorevoli, a gettar l’ancora e a ripararsi nella baia di San Vincente, in Portogallo. Dove, giusto per la storia, anni dopo sarebbe approdato naufrago, aggrappato a un relitto, un marinaio genovese di nome Cristoforo Colombo.
Poco distante vi è la residenza estiva dell’Infante don Enrico, regnante in Portogallo, promotore di una vera e propria scuola nautica nella vicina fortezza di Sagres, a strapiombo sul promontorio, punto di partenza per la conquista dell’Ultramar portoghese, che comprende l’ancora poco esplorata costa africana.
Due sono i motivi fondamentali della politica atlantica voluta dal regnante lusitano, già Gran maestro dell’ordine religioso e militare di Cristo: il primo religioso, cioè combattere contro i Mori; il secondo, non meno importante, economico: oro, schiavi da avviare ai mercati europei, spezie, pesce, legname, oro, animali e altro, nonché procurare nuovi terreni per le piantagioni di canna da zucchero, in cambio di chincaglieria, fussare, vesti, cavalli. Gli stranieri in Lusitania sono i benvenuti, specie se provetti navigatori, magari di fama, come i veneziani.
L’incontro è inevitabile. I fratelli veneziani si separano: Antonio continua il viaggio, Alvise viene convinto dal veneziano Patrizio di Conti, consigliere dell’Infante don Enrico a navigar verso l’Ultramar africano per conto della corona portoghese.
Capita certe volte che, a metà di un viaggio, si decida di cambiar rotta. Come nella vita, che un percorso consueto si trasformi in un’avventura verso l’ignoto.
Così, il secondo giorno di primavera del 1455, il giovane Da Mosto prende il mare alla guida di una caravella da 90 botti di Vicente Diaz, un fuscello nell’Atlantico malgrado gli alberi e la chiglia rinforzati, con l’intenzione di navigar verso gli arcipelaghi (Porto Santo, dove era governatore il piacentino Bartolomeo Perestrello, una delle figlie del quale andò poi sposa a Cristoforo Colombo), Madera, le Canarie (di cui il Da Mosto offre preziose informazioni) oltre il capo Bojador, il limite delle coste esplorate. Al veneziano, per contratto, quattro parti su dieci del guadagno dell’impresa.
Alvise stesso traccia di suo pugno le note dei due viaggi verso l’ignoto, compiuti a distanza di un anno l’uno dall’altro. È un racconto appassionante, ricco di particolari, competente. Da vero giornalista di viaggio, per intenderci della specie di Marco Polo e di Marin Sanudo. Le relazioni, scritte probabilmente nel 1464 al ritorno in patria, ci sono giunte attraverso quattro trascrizioni diverse, tra cui il manoscritto Marciano, probabilmente la versione più antica. Già di proprietà del principe Eugenio di Savoia, venne acquisito nel 1928 dalla Biblioteca veneziana. La mappa dipinta da Francesco Grisellini, una grande tela in bella mostra nella Sala dello Scudo a Palazzo Ducale, aiuta a ripercorrere le tracce del navigatore veneziano: Porto Santo, Madera, le isole Canarie, Cavo Blanco e poi giù, sempre in vista di costa, lungo quel territorio d’Africa chiamata allora Ethiopia, descrivendo minuziosamente luoghi e sistemi di vita. Poi gli antichi nomi con cui la spedizione battezzò i luoghi d’approdo sembrano confondersi con quelli riportai sulle carte geografiche attuali.
Da Mosto avvista ed esplora la foce del fiume Senega, le saline di Tegazza, annota con particolare cura il sistema, detto commercio silente col quale, senza vedersi né parlarsi, avviene lo scambio fra oro e sale tra popoli confinanti e belligeranti. S’inoltra all’interno del sud del Senegal, alla corte del re Budomel, dove la spedizione portoghese (non dimentichiamo per conto di chi Alvise navigava) viene ospitata per diversi giorni. Il racconto si fa oltremodo interessante quando il veneziano narra della fede maomettana e dell’abbigliamento degli africani:
«il vestir di questa gente è che tutti vanno nudi… salvo che portano un cuoro di capra messo in forma d’una braga, con che si cuoprono le vergogne…»
E poi scrive dettagliatamente delle armi usate nelle guerre fra di loro, della valenza natatoria, delle cinquanta capanne del villaggio, della casa del re e delle sue nove mogli, dei costumi lussuriosi, del gran seguito di cortigiani, dello strano protocollo di corte, del mangiar «per terra bestialmente» tutti mettendo le mani nello stesso piatto, delle colture, dei piccoli fagioli dall’occhio, conosciuti dagli egizi e dai romani (oggi andati perduti) del vin di palma che sembra latte, di come si estrae e del gusto che varia a seconda dei giorni. Degli animali, grandi bisce, piccole vacche pezzate, leoni, leopardi, caprioli e lepri. Elefanti selvatici, pappagalli dagli strani nidi che danneggiano le colture, galline faraone e oche molto diverse da quelle europee.
* * *
Il navigatore ha modo poi di visitare un mercato, una fiera, come si direbbe oggi: questa è la descrizione che ne fa, divagando anche in altro tema. Il testo è tratto da Le Navigazioni Atlantiche del veneziano Alvise Da Mosto, volume curato da Tullia Gasparrini Leporace e stampato (in tiratura limitata nel 1961) per i tipi del Poligrafico — Libreria dello Stato.
«Perché el me acade star in tera molti zorni, determinai de andar a veder uno suo merchado, osia fiera, che se fasìa suso in una prataria non molto lontan dal quel luoco dove io giera alozado, el qual se fasea un luni o veneri: e sì ge andai doe over tre volte, sì per veder se li fosse cosa per lo facto mio sì etiam per esser ben vestito, et alchuni me tocavano le veste quasi per un miracolo, maxime done, che mai più haveano veduti homini bianchi e vestiti.
A questo merchado venìa homini e femine del paexe circostante a quatro over cinque milia, ché quelli che stavano più lonzi andavano ad altri merchadi, perché ancho altroe se costumava de doverse far. E in questi merchadi compresi molto ben che costoro son zente poverissima, a rispeto a le cosse che portavano suso quel merchado a vender: el giera prima gottoni, ma non filadi e non in quantità, e non molti pani de gotton, e legumi, melio, olio, chonchete de legno, stuore de palma, e tute altre cosse di che se servono per suo viver. E cossì portano li homini come le femine a vendere; e vendeno li homini di quelle soe arme; e alguni pur portano qualche oro da vender, ma de tuto pocha cossa. E non se vende niente per dinari, perché el no giè moneda alguna, né se costuma salvo a baratar cossa par cossa e due cosse per una cossa, e tutto lor mercha’ se fa a barato.
Questi Negri, sì mascoli como femine, me vegnìa a guardar per una maravelia, e parevali nova cossa a veder un christian in simil luogo e mai per avanti non visto; e non de meno se meraveliaveno del mio habito che de la mia biancheza — el qual habito giera a la spagnola con un zupon de damascho negro e un mantelìn de pano griso — e guardavano el pano de lana che lor non l’àno e guardavano el zupon, e molto se stupavano; e algun me tocava la man e le braza e con spudaza me fregava, per veder se la mia biancheza giera tentura over carne; e vedando pur che giera carne biancha, stavano meraviliosi, et maxime alcune de quele soe done zovene me faceano alcuni soi acti per i quali ben intendeva la loro voluntà, ma pocho li zovava perché havea altre fantasie che de simel cosa, pur me intrava alcuni mali spiriti ne la mente de alcune garzonete de circa sedece anni in desdoto, chi erano nude e chi meze nude, ma mai non gli fu altro peccato, se lassavano tochar ciò ch’io volea pur ch’io li havesse donata quache fussara.
A questi merchadi io andava per veder cosse nuove, e ancho per veder se ’l giera algun che avesse suma de oro da vender: ma del tuto se atrovava pocho, como ho predito.
Le femine de questo paixe sono molto ioconde e alegre, e cantano e balano volentera, e specialmente le zovene; ma non balano salvo a la luse de la luna, et el suo balar è molto differente dal nostro».
Così scrive il navigatore, lasciando ben intendere quello che cercava. Ma non aveva trovato certo l’Eldorado.
Continua poi la descrizione trattando del valore dei cavalli e degli strani finimenti, della malattia per cui non possono pisciare e crepano. Narra dello stupore dei negri (li chiama così) una volta portati a bordo della nave, alla vista di tutte quelle diavolerie che gli europei adoperavano per navigare.
Poi, ripartiti per mare, oltre Capo Verde (promontorio dirimpetto l’odierna Dakar) l’incontro con Antoniotto Usodimare, collega genovese particolarmente oberato da certi debiti lasciati in patria.
Il viaggio continua in coppia. Le due caravelle s’imbattono prima in alcune secche, poi in tre isolette ricche di nidi e dalle acque pescosissime. Descrive gli abitanti (Sereri, gran idolatri, crudelissimi e senza leggi) e il territorio del Rio de’ Barbacini, e infine il tentativo di mandare un trucimano (esploratore negro facente parte dell’equipaggio) sulla spiaggia a tentare di comunicare in qualche modo col gruppo di uomini che s’era radunato alla vista delle strane vele bianche sul mare. Nonché di come questo fosse stato crudelmente ammazzato e squartato, e i pezzi del corpo mostrati ai marinai che avevano assistito alla scena dalla nave.
La prima navigazione termina col tentativo d’inoltrarsi lungo il corso del fiume Gambra (Gambia). Mentre la caravella grande rimane alla fonda, quella più piccola risale il fiume, ma i nostri sono costretti, da piogge di frecce avvelenate e dalla ferma volontà dei marinai di tornare in patria, a fare retromarcia verso il Portogallo.
Tra queste pagine anche tratti di vena poetica, quando Alvise racconta di aver visto, per la prima volta, una nuova costellazione. Sei stelle basse sopra il mare, in direzione sud, disposte a forma di croce: il «Caro de ostro», la croce del sud. Per veder le nuove stelle bisognava aver «perduta la tramontana», cioè arrivare talmente vicini alla linea dell’Equatore da perder di vista la Stella polare.
* * *
Nel maggio dell’anno seguente, 1456, Alvise e Antoniotto armano di nuovo due caravelle e ritornarono a gran velocità oltre Cavo Blanco. Ma un violento fortunale li sorprende sballottando i fuscelli di legno e tela per due notti e tre giorni. Al placarsi della bufera la sorpresa della vista di alcune isole. Sbarcano nella prima che incontrano, che ribattezzano Boa Vista (Buona Vista). Disabitata, come le altre che perlustrano nei giorni seguenti, ma foltissima di vegetazione e di colombi che non avevano mai visto prima l’uomo e che si lasciavano prendere con le mani. Una volta fatto scorta d’acqua e vivande le caravelle ritornano sulla rotta originaria, lasciando l’arcipelago in mezzo all’atlantico al largo di Capo Verde.
Il veneziano quindi, con l’amico genovese, fu il primo a scoprire queste isole, chiamate poi Isole di Capo Verde, delle quali poi prese possesso, in nome della corona portoghese, un altro ligure, Antonio da Noli.
Alvise e Antoniotto risalgono nuovamente il fiume Gambia. Qui sbarcano e hanno modo di comunicare e commerciare con le popolazioni locali. Parla anche di oro, il nostro navigatore, ma in quantità trascurabile. Si sofferma sulla fauna: gatti maimoni, babbuini, la caccia all’elefante e il gusto della carne del pachiderma. Parla poi di uno strano essere, il «pesso cavallo» (ippopotamo) che scappa dalla riva del fiume a nascondersi immergendosi completamente sott’acqua, dei «vespertillioni, cioè nottole» (pipistrelli). Parla per primo dei grossi alberi (baobab) dal tronco traforato, di uno strano pranzo alla veneziana, della fertilità della terra.
La seconda navigazione continua, sempre più spingendosi verso sud a battezzar nuovi promontori e isolotti magari col nome di battesimo del marinaio morto per la febbre, ben attenti, in quel mare ignoto, a schivar scogli e secche. Nuove foci di fiumi, uno grandissimo scambiato addirittura per un golfo, altre isole (Bissagos). Il pericolo dato dalle forti correnti atlantiche e l’incapacità di comunicare con le popolazioni di questi luoghi (a parte lo scambio di qualche «fussara»), assieme al pericolo di sconosciute malattie, suggeriscono la conclusione di questa seconda avventura africana del Da Mosto:
«… e vegnemo verso le parte nostre de’ christiani, a le qual per nostre zornate navigamo tanto che Dio per sua gratia, quando el ge piase, ne conduse a bon porto».
Con queste parole termina il diario di viaggio di Alvise Da Mosto, e pure lo scarno sunto che ne abbiamo fatto. Infruttuosi, comunque, i suoi due viaggi non furono, specialmente il secondo, se è vero che, quando il primo febbraio 1464 Alvise lascia il Portogallo per ritornare a Venezia, non sembra mancargli di che rimpinguare le disastrate finanze della famiglia.
* * *
La vita di Alvise Da Mosto, in Venezia, continua con l’affidamento da parte della Serenissima di vari incarichi diplomatici e di governo. Ma questa è un’altra storia, ben più lunga e complessa delle due navigazioni atlantiche. Figura particolare comunque, quella del giovane navigatore in proprio. Venezia e gli storici, certo per sovrabbondanza di personaggi e vicende, hanno lasciato la figura di Alvise «tra color che son sospesi». Nel bene e nel male è stato uno dei primi veneziani, se non addirittura il primo, a navigare lungo l’Africa. Non aiuta a dare il vero valore alla figura del navigatore la polvere dei secoli caduta copiosa sui traslochi d’archivi patrizi o la dispersione attraverso non sempre nobili mani di tanti elementi. Le vicende del periodo veneziano di Alvise Da Mosto e della sua famiglia sono peraltro raccolte nell’interessante volume firmato da Andrea Da Mosto, edito dalla Regia Deputazione nel 1928. Attraverso la meticolosa consultazione dei documenti custoditi negli archivi della Serenissima, custode superiore della propri storia attraverso la scrupolosa annotazione di tutti gli accadimenti, l’autore lascia trasparire uno spaccato della potenza marinara lagunare, nella seconda metà del quattrocento, dalle venature decisamente complesse, irte di controversie.
* * *
Giovanni, il padre di Alvise, contribuì decisamente all’impopolarità della famiglia attraverso malaugurate scelte politiche e speculazioni dimostratesi foriere di disgrazie. Alvise e il fratello Antonio stessi dovettero abbandonare i broli familiari della zona della Tor da Mosto alla sentenza di esilio del padre, trovandosi vittime delle usurpazioni dello zio Bartolomeo, dopo che il padre aveva sposato, in seconde nozze, una veronese che era più interessata alle rendite che ai figli che il marito aveva avuto dalla prima moglie, Giovanna Querini, nell’avito palazzo sul Canal Grande, in rio SS. Apostoli, monumento di stile bizantino-lombardo che sembra sempre in via di ristrutturazione ma rimane lì com’era quand’era albergo Leon Bianco.
La via sulle tracce di Alvise è comunque ancora in gran parte da percorrere. Vi è una tomba introvabile, reperti cartacei relativi alle navigazioni sparsi qua e là, magari ancora da catalogare. Tracce di antichi affreschi.
A Venezia, nell’entroterra. Forse negli archivi dei Genovesi, probabilmente in Portogallo, sicuramente nelle zone degli approdi africani, prova ne è che nel 1988 una studentessa senegalese si laureò in lettere a Venezia nientemeno che con una tesi sulla tradizione orale senegalese relativa agli episodi narrati dal Da Mosto nel suo diario.
Incuriosisce, la figura del veneziano, anche oggi, come incuriosì l’abate Placido Zurla del quale, nel 1815, la Tipografia di Alvisopoli pubblicò un saggio a mo’ di dissertazione (dalla sintassi urticante) in cui si ridava ad Alvise il suo in merito alle scoperte africane.
Altre cose, seppur venute alla luce, devono ancora essere ben valutate: il portolano a lui attribuito, le indicazioni date ai cartografi dell’epoca, in primis al camaldolese Fra Mauro, per la compilazione delle mappe geografiche. E altro, storicamente e umanamente parlando.
NOTA — Un grazie infinito all’amico padre Gianfranco Gottardi ofm per il materiale che mi ha inviato dall’Africa, tra cui un’edizione della Storia della Guinea Bissau (che cita il Da Mosto) e un’edizione pregiata dei Viagens de Alvise da Cadamosto in portoghese stampata nel 1929 dall’Academia Portuguesa de Istoria.
Grazie anche a Jeanne Marie E. Turpin, signora senegalese, che nel 1988 si laureò in Lettere all’Università veneziana Ca’ Foscari, con una tesi dal titolo: Per un commento delle Navigazioni atlantiche del veneziano Alvise da Mosto, in particolare con la tradizione orale senegalese. C’è molto da imparare