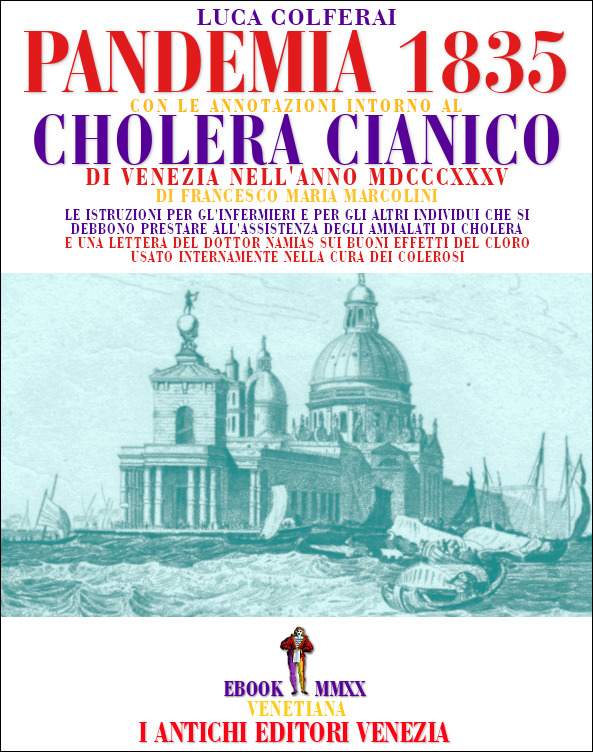Fra danze maori
e rivolte del rum
«Il mio folle temerario giro del mondo», IV puntata
Prosegue imperterrita la demenziale crociera intorno al mondo del medico-scrittore pluripremiato Giorgio Bertolizio (ultimo riconoscimento il prestigioso Premio Nabokov) con la complicità della leggiadra consorte, la celebre modista Vera Storani. Indagando con acutezza e ironia sul passaggio tra mito e realtà sulle orme di Giulio Verne e sull’esempio del «Giornale di viaggio» di Michel de Montaigne, l’autore racconta il suo peregrinare città dopo città, Paese dopo Paese, con esiti ora esilaranti ora deprimenti. Ne vien fuori un originale e scriteriato diario di bordo. Volendo, potete rileggere le tre puntate precedenti richiamandole con i loro titoli dalle pagine del nostro archivio elettronico: «Il mio folle temerario giro del mondo», «Dagli incubi di Gaudì ai fantasmi del Corsaro», «Aspettando i cannibali tra i fiori di cactus». Buona lettura.
AUCKLAND, 23 FEBBRAIO
La storia della città iniziò intorno al 1350, proprio quando si stava completando il Palazzo dei Papi in Avignone, con la creazione di villaggi fortificati da parte dei maori. Evidentemente, anche prima dell’arrivo degli europei, i nativi non conducevano una vita pacifica. Il primo europeo a posare i piedi in Nuova Zelanda fu Abel Tasman, il 16 dicembre 1642, accolto in maniera indimenticabile dai maori. Tasman, infatti, chiamò il luogo dello sbarco, situato all’estremo nord dell’Isola del Sud, Murderers Bay, in memoria di quattro marinai uccisi. Oggi, la località è una meta turistica molto frequentata, col più invitante nome di Golden Bay. Dopo la sanguinosa esperienza, è probabile che Tasman si sia limitato soltanto a costeggiare parte dell’isola. Nondimeno, molti luoghi portano il suo nome: Fiume Tasman, Monte Tasman, Ghiacciaio Tasman e Baia di Tasman. Per farla breve, dopo questa esperienza, soltanto successivamente al passaggio nel 1769 di James Cook, cominciò la colonizzazione di Aoteraoa (Terra della Lunga Nube Bianca). Dapprima fu cautamente commerciale ma, quando gli europei ebbero a disposizione più efficienti armi da fuoco, indispen-sabili per evitare rovinosi corpo a corpo con i muscolosi maori, l’aggressione militare divenne metodica.
La Nuova Zelanda è orgogliosa dei propri emblemi che affondano le radici nel passato lontano e anche recente: un animale, un frutto e una torta. Simbolo della giovane nazione è il kiwi, un uccello preistorico grosso come un pollo, con ali atrofizzate e un ridicolo becco a forma di cannuccia ricurva. Depone uova sei volte più grandi di quelle di gallina dimostrando che, con un po’ di fortuna, possono sopravvivere nei secoli anche gli scherzi di natura. Con il medesimo nome è chiamato il frutto oblungo dalla buccia pelosa, originario della Cina meridionale, che i neozelandesi hanno coltivato intensivamente e che ha ormai invaso l’Europa. Anch’io, nella mia casa di campagna, sono caduto nel tranello di realizzare un pergolato di kiwi. Pianta straordinaria che non viene colpita dai parassiti, non soffre di malattie e produce frutti senza bisogno di alcun concime. Unico difetto della tipologia di kiwi che ho piantato: in alcuni momenti le foglie emanano un odore nauseante, come se nei dintorni vi fosse qualche gatto putrefatto. Invece, il dolce nazionale neozelandese è la Pavlova, una meringa dolcissima, coperta di panna montata e fettine di fra-gole e kiwi, creata da uno chef di Wellington in onore della ballerina russa Anna Pavlova. Gli australiani, però, contendono ai neozelandesi l’invenzione di questa bomba calorica e subdola arma di distruzione di massa. Con i simboli neozelandesi, chissà come mai, i maori fanno la figura dei nuovi arrivati, anche se la politica coloniale britannica, sul piano culturale e giuridico, è tradizionalmente de-scritta come lungimirante, forse perché in Nuova Zelanda furono inviati volonterosi borghesi anziché galeotti, prostitute e disperati in genere.
Oggi, la propaganda sull’assoluto rispetto per le tradizioni maori esalta soprattutto il profondo significato mistico dei loro tatuaggi. Tanto il moko facciale quanto il whakairo, che si estende dalla vita alle ginocchia, natiche e parti genitali comprese, sarebbero la sintesi grafica della genealogia, della personalità e dello stato sociale di un individuo. Costituirebbero, insomma, una sorta d’indelebili marchi metafisici, irripetibili e unici come le impronte digitali. Tuttavia, non ho appurato se, dalle linee, triangoli e ghirigori, sia possibile desumere le propensioni erotiche del soggetto. Persino i tre colori più usati nei tatuaggi avrebbero un profondo significato trascendente, rappresentando la mascolinità e l’uscita dal mondo delle tenebre (nero), la terra madre e la nascita (rosso) la luce e il mondo fisico (bianco). Ed anche i tatuaggi delle donne maori, limitati alla fronte e al mento, manifesterebbero un analogo contenuto spirituale, se ho capito almeno in parte quello che mi è stato spiegato. Giacché l’ontologia non è stata mai il mio forte, ho cominciato a nutrire una profonda invidia per i maori, che riescono a rivelare graficamente il proprio essere. Gli psicanalisti, invece, dovrebbero sentirsi umiliati. Tuttavia, astrazioni a parte, le terre rimaste nelle mani dei maori, ossia del 14% della popolazione neozelandese, non solo costituiscono soltanto il 4% del territorio nazionale, ma sono anche particolarmente povere. L’esaltazione della cultura maori e quella dei nativi nordamericani hanno una strana somiglianza. Forse, vogliono far dimenticare spoliazioni e soprusi d’ogni genere, oltre a una propaganda che li aveva descritti come feroci selvaggi. Le notizie sul cannibalismo dei maori cominciarono a circolare in Europa quando l’unico superstite di un drappello, guidato da Marion Dufresne, raccontò la tragica fine dei suoi commilitoni. Il 16 giugno 1772, l’esploratore francese, che da circa in mese intratteneva rapporti amichevoli con una tribù maori, accompagnato da sedici uomini di scorta si recò a pescare. Sennonché, senza alcuna ragione apparente, furono assaliti dagli indigeni, squartati e divorati. Semplicemente, avevano infranto un tabù religioso pescando in una baia dove, qualche tempo prima, erano affogati alcuni loro parenti. Paese che vai, usanza che trovi. La reazione francese fu esemplare: numerosi capi villaggio furono uccisi e tutte le capanne dei dintorni furono incendiate. Naturalmente, è abbastanza facile giustificare lo sdegno provato dei buoni cristiani europei verso l’antropofagia, anche se nella narrazione dell’Ultima Cena non è difficile intravedere, irriverentemente, una sorta di cannibalismo metafisico.
A tale proposito, la pubblicizzata cucina tradizionale maori, è un’impostura. In Nuova Zelanda, com’è noto, non esistono specie endemiche di mammiferi, salvo alcuni pipistrelli gastronomicamente poco invitanti. Curiosamente, però, i millantati cibi tipicamente maori sono le carni di maiale, agnello e pecora. Perciò, certamente si tratta di ricette elaborate dopo l’abolizione per uso alimentare della carne umana, quando gli inglesi avevano invaso culturalmente e culinariamente il remoto arcipelago. Ovviamente, il divario tra cultura e arte culinaria britannica è più vasto del canale della Manica. Peraltro, non si può negare che parecchi maori abbiano appreso rapidamente, non soltanto differenti abitudini alimentari, ma che i sentimenti caritatevoli e altruistici non erano adatti a individui civilmente evoluti. Dal 1818 al 1835, infatti, i maori più ‘civilizzati’, che avevano appreso l’impiego delle armi da fuoco, scatenarono le cosiddette ‘Guerre del moschetto’, ossia una serie di conflitti tribali dapprima contro le tribù confinanti e, in seguito, per la conquista di territori più lontani e per i quali gli europei non nutrivano alcun interesse. Celebre, a tale proposito, è lo sterminio dei moriori avvenuto nell’inverno del 1835. I moriori erano un gruppo di maori che aveva abbandonato, intorno al 1500, la Nuova Zelanda per insediarsi nelle Isole Chatham distanti 800 chilometri. Isole fredde e inospitali tanto che i moriori, furono costretti a vivere cacciando foche e uccelli marini. Sicché, per non estinguersi, bandirono gli scontri armati e il cannibalismo. Non avevano fatto i conti, però, con un migliaio di maori della regione di Taranaki che, giunti in due ondate, su navi europee, e armati di fucili e asce, li massacrarono e divorarono i loro cadaveri, dimostrando un formidabile appetito. I pochi superstiti, dei circa due mila moriori, furono fatti schiavi e l’ultimo moriori purosangue, Tommy Solomon, che di moriori non aveva nemmeno il nome, morì nel 1933.
Con il Trattato di Waitangi, sottoscritto il 6 febbraio 1840 e che d’imbroglio puzzava lontano un miglio, i capi maori cedettero, spontaneamente e pacificamente, alla regina Vittoria tutti poteri sull’Isola del Nord. Sicché, i maori non tardarono a capire che i veri nemici erano i colonizzatori e che per intimorirli non erano sufficienti danze guerriere e linguacce. Infatti, dal 1863 al 1872, il movimento Hauhau, definito dai vincitori ‘antibritannico e anti-missionario’, diede parecchio filo da torcere agli inglesi. Un movimento che, anche per le sue strambe connotazioni religiose, era destinato inevitabilmente al fallimento. Ad Auckland, i primi europei arrivarono soltanto nel 1820 provocando un crollo demografico nei villaggi maori, probabilmente più per l’importazione di malattie, contro le quali gli autoctoni non avevano sviluppato difese immunitarie, che per l’uso delle armi da fuoco. Infatti, per gli europei fu più conveniente comprare dai capitribù maori — che conducevano una vita da cacciatori-raccoglitori e dunque non seminavano un bel niente — vasti terreni in cambio di qualche utensile. Sicché, per un motivo o per un altro, ad Auckland i maori costituiscono soltanto il 10% della popolazione locale. Auckland, situata sopra un’area vulcanica, presenta spiagge splendidamente deserte, circostanti rigogliose foreste e coni vulcanici estinti con panorami mozzafiato. Urbanisticamente, però, è una città moderna abbastanza mediocre, sviluppatasi caoticamente in modo intensivo. Perciò, spesso, la distanza che separa le abitazioni private, prevalentemente piccole ville, supera di poco il diametro di un ombrello spalancato. Anche a Venezia, parecchie calli sono altrettanto strette, ma i venetici non disponevano di terreni estesi. Ho apprezzato assai il suo clima ventoso e mutevole, che in sei ore è cambiato almeno dodici volte, essendo stato informato che, nei giorni invernali senza vento, lo smog avvolge la città in modo pestilenziale. Ho ammirato molto meno il Giardino d’Inverno, collocato in uno splendido parco, che ricrea una finta foresta pluviale con ridicoli uccelli di lamiera. La Sky Tower alta 328 metri, invece, l’ho vista soltanto dal basso e non mi ha impressionato più di tanto. Secondo le statistiche, Auckland è una città con alto tenore di vita e benessere altrettanto diffuso. Il suo porto, straripante d’imbarcazioni a vela, donde il anche nome di City of Sails, ne sarebbe l’emblema. Le barche sono tanto numerose, stipate in modo impressionante e apparentemente identiche, che sembrano essere un’illusione pubblicitaria di cartone.
Tuttavia, nelle vetrine di molti negozi, apparentemente di lusso, ho visto in vendita oggetti qualitativamente mediocri e di pessimo gusto. I giovani seduti nei bar si guardavano in faccia senza parlare e i numerosi mendicanti sdraiati in terra, che ho osservato nella via più centrale, forse sono sfuggiti al censimento nazionale. Mi sono stupito un poco di non aver visto saloni nautici, che forse ci sono in parti della città che non ho percorso, con l’amo per accalappiare velisti danarosi, ma mi ha sorpreso davvero molto l’assenza di adeguate esche preziose per le loro consorti o accompagnatrici occasionali. Quando si passeggia senza una meta precisa, sono parecchie le stupidaggini che vengono in mente. Insomma, Auckland sarà pure una delle metropoli più vivibili del pianeta ma, probabilmente, per gli amanti della monotonia agiata. Auckland, tuttavia, è una delle poche città al mondo ad avere due porti su bacini marittimi distinti: il porto di Manukau e il porto di Waitemata. Se non avesse nemmeno questa particolarità, perché mai dovrebbe essere il paradiso dei velisti?
WELLINGTON, 25 FEBBRAIO
Capitale più a sud del nostro pianeta, è nota come ‘The City of Wind’ mentre, nel 2011, la Lonely Planet, casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, ha conferito alla città addirittura l’antipatico titolo di ‘più piccola capitale cool del mondo’. Mi sono chiesto, perciò, mentre osservavo da lontano le sconsolanti coste neozelandesi, perché diavolo, nel pieno dell’estate australe, stavo dirigendomi a prendere una botta di freddo. Sapere che a Wellington esistono più caffè pro capite che a New York, non mi ha consolato. Non ero arrivato fino a laggiù, per rintanarmi in un bar in capo al mondo. La ventosa Wellington ci ha accolto, senza un alito di vento, con il cielo nuvoloso e una temperatura autunnale, nel suo porto invaso da cataste di legname come se si fosse appena disboscata mezza isola. A prima vista, è stato arduo ritenerla una città proiettata nel futuro, per gli eventi culturali ad alto profilo, giacché i suoi negozi sembravano fermi ai nostri anni Sessanta, almeno per quanto riguarda i capi d’abbigliamento. Non dubito, certamente, che offra una vita notturna particolarmente vivace, anche se è difficile immaginarla in un luogo dove si cena alle sei di sera, mentre le rivendite di tabacchi e di bevande alcoliche sembrano aver abbassato le serrande per fallimento da parecchio tempo. Abbastanza interessante è il Museo Nazionale (Te Papa Tongarewa Museum), se non si ha l’aspettativa di entrare al Louvre, soprattutto per i frammenti superstiti dell’annientata cultura maori. Per niente appassionante, invece, è stata la visita del Giardino Botanico i cui rosai, all’aria aperta, erano tristemente rinsecchiti. Nondimeno, all’interno di un capannone, mi sono trovato a fotografare, come uno scemo, fiori di ninfee. D’altra parte, Wellington è diventata capitale della Nuova Zelanda, soltanto nel 1865, detronizzando Auckland. Supremazia preconizzata sin da quando la primitiva Port Nicholson assunse il nome del vincitore di Waterloo. In realtà, la questione della sua fondazione mi è sembrata piuttosto confusa, forse perché il primitivo insediamento degli europei, nella tranquilla e pittoresca baia circondata da colline, avvenne in località diverse anche se vicine: Poneke (donde forse la trasformazione in Port Nick) e Peto-one. Da buon turista che si accontenta di quattro notizie storiche messe in croce, non ho approfondito la faccenda.
Questioni topografiche a parte, una prima avanguardia di coloni giunse nella futura Wellington a bordo della nave Tory, il 20 settembre 1839 e fu seguita, il 22 gennaio 1840, da 146 avventurosi (35 coppie maritate, 36 single e 40 bambini) sbarcati dalla nave Aurora. Probabilmente, non ebbero particolari problemi con i locali maori ma si tratta di una congettura. Infatti, trascorsi meno di trecento anni, sembrano avvenimenti accaduti nella preistoria. Giacché la città è situata all’estremo sud dell’Isola del Nord, mi è sorta la stravagante idea che gli abitanti di Wellington abbiano una straordinaria predilezione per paradossali accostamenti. L’area intorno al porto, trasformata in una palude dai terremoti del 1848 e del 1855, è diventata il Central Business District, quasi che gli affari affondino le loro radici nella melma. La non distante isola di Matiu, da luogo di quarantena e campo d’internamento nei due conflitti mondiali, è diventata un’oasi per la protezione di specie animali in pericolo d’estinzione, come a dimostrare che malati infettivi e prigionieri di guerra erano vissuti in un paradiso terrestre. A ben vedere, sulla città di Wellington ho scritto davvero poco. Tuttavia, quando in un giro turistico, viene fatto ammirare uno stadio sportivo — nella circostanza il Westpac Stadium, affettuosamente soprannominato ‘Tortiera’ ( Cake-Tin) — che cosa mai si può pretendere?
SYDNEY, 28 FEBBRAIO — 2 MARZO
A James Cook è attribuito il merito d’aver intuito che l’Australia è quasi un continente. L’Australia, infatti, in un certo senso, fu più facile da raggiungere che da ‘scoprire’. Il primo europeo a mettere piede sull’immensa isola, il 26 febbraio 1606, fu l’olandese Willem Janszoon. Sbarcato sulle rive del fiume Pennefhater, che sfocia nel Queensland, vicino all’odierna Weipa, ossia sulla costa occidentale della penisola di Capo York, l’audace navigatore, credendo d’essere ancora in Nuova Guinea, ritenne inutile esplorare una regione paludosa, popolata da indigeni inospitali e aggressivi. Sicché, giunto a sud della baia di Albatross, invertì la rotta e impose il nome a Capo Keerveer, in perenne ricordo del suo dietrofront. Dirk Hartog, veleggiando lungo le coste australiane occidentali, il 25 ottobre 1616, affisse una targa di peltro in cima a un palo, sull’isola che porta il suo nome situata al largo di Shark Bay, dimostrando un profondo disinteresse per la terra sconosciuta. Abel Tasman, nel 1644, esplorò invece la fascia costiera settentrionale dell’Australia, conferendole il nome di New Holland, e ne stilò una descrizione accurata, dei luoghi e degli abitanti, talmente entusiasta che a nessun europeo venne voglia di visitarla, almeno di propria spontanea volontà. Difatti, a passare casualmente da quelle parti, nel 1688, fu il pirata-esploratore William Dampier, ma su una nave corsara che veleggiava verso l’India. Una decina d’anni dopo, Willem de Vlamingh giunse fino all’attuale Perth, ma non proseguì oltre. Sarà, perciò, soltanto l’inglese Mattew Flinders a circumnavigare l’Australia, tra il 1797 e il 1802, e a dimostrarne l’insularità. Insomma, sino all’epoca di James Cook, della sconosciuta Australia si era parlato poco e male. Cook, a bordo del brigantino Endeavour, nel 1770 calò l’ancora nei pressi di Botany Bay, situata pochi chilometri a sud di Sydney. La baia, inizialmente, da Cook fu battezzata Stingray Harbour ma il botanico della spedizione, il ventisettenne Joseph Banks, entusiasta della vegetazione che aveva trovato, soprattutto perché era arrivato in una stagione favorevole, volle che fosse chiamata Baia della Botanica. Banks era individuo davvero colto che, dopo aver sopportato, dal 1768 al 1771, i disagi della vita di bordo, era pronto ad affrontare una nuova esperienza con le comodità che poteva permettersi. Sicché, quando Cook decise d’intraprendere un altro viaggio, che durerà dal 1772 al 1775, volle di apportare sostanziali modifiche alla nave Resolution. Cambiamenti che Cook giudicò pericolosi per la navigazione e li fece smantellare. Sicché, Banks si rifiutò di seguirlo, perché non intendeva rinunciare una seconda volta ai propri agi per collezionare piante sconosciute. In ogni caso, fu l’ammiraglio inglese Arthur Phillip a fondare, nel 1788, la colonia britannica di New Albion, nel Nuovo Galles del Sud, che presto divenne Sydney in onore di Thomas Townshend, 1° visconte di Sydney, cui nel 1785 era già stato intitolato un insediamento nella Nuova Scozia in Canada, dal colonnello svizzero Joseph Frederick Wallet Des Barres. Si deve desumere che le doti politiche del visconte Townshend, per meritarsi tanto onore, fossero davvero notevoli durante il regno di Giorgio III Hannover, precoce disturbato mentale, disgraziatamente longevo e responsabile della Guerra d’Indipendenza americana.
Arthur Phillip, con l’autorizzazione di Townshend, per favorire l’immigrazione in una terra tanto lontana, scelse una politica lungimirante, attuando una massiccia deportazione di detenuti. Gli australiani, però, tendono rimarcare che si trattò, se non proprio di ladri di galline, d’individui colpevoli di crimini minori o addirittura d’innocenti esiliati per ragioni politiche ignominiose. Naturalmente, non si può pretendere d’avere sempre antenati dei quali andare fieri. Ma certamente le 237 prostitute e borseggiatrici, inviate nel 1789, con la nave Lady Jordan, dall’Inghilterra a Sydney, devono aver lasciato qualche indesiderato erede. Gli europei, al loro arrivo, incontrarono ovviamente gli indigeni che abitavano, da 40 o 50 mila anni, sull’isola, ossia i cosiddetti aborigeni. Quanti fossero, su tutto l’immenso territorio, è oggetto di congetture, perché i colonizzatori non persero tempo a contarli da vivi e, tanto meno, da defunti. Degli aborigeni, provenienti originariamente dall’Indocina, etnicamente non omogenei, è difficile ricostruire la storia, le usanze e la cultura, anche perché sembra parlassero 200 o 600 linguaggi diversi, quasi tutti scomparsi, non conoscevano la scrittura ed erano sparpagliati, su un territorio enorme, in piccoli clan. Sicché, accanto a descrizioni accurate dello stile di vita di alcuni gruppi affini, si trovano generalizzazioni di dubitabile autenticità, se non altro per le differenze climatiche esistenti in Australia. Ho letto, ad esempio, che la nudità completa era consentita ai maschi dai 18 ai 29 anni, giacché i ragazzi tra gli 11 e i 17 si coprivano i genitali e non il sedere, mentre gli anziani tra i 30 e i 50 anni facevano l’esatto contrario. Ammesso che si tratti di notizie attendibili e trascurando la mancanza di dettagli sull’abbigliamento dopo la cinquantina, forse perché erano già morti, si tratta di curiosità che lasciano il tempo che trovano, tanto quanto le descrizioni sul loro modo di cucinare il pesce o la selvaggina.
Altrettanto arduo è stabilire la loro indole, ma è difficile immaginare che fossero feroci. Si sa, infatti, che gli aborigeni australiani usavano il boomerang, nome derivato dal termine “bu-mar-rang” della tribù Turuwal, quale arma per la caccia o per i combattimenti tribali. Pur non essendo un esperto, ho l’impressione che colpire un animale in movimento, con tale arnese, richieda, nel corredo cromosomico del lanciatore, un gene della fortuna straordinariamente prepotente. Non a caso, la curiosa arma ha avuto enorme successo nei cartoni animati o nei film comici. Tuttavia, nonostante il micidiale strumento, gli aborigeni australiani furono decimati, sia con importazione di malattie, contro le quali non possedevano difese immunitarie, sia con battute di caccia all’uomo, da parte di volonterosi cittadini (come i tremila aderenti alla Black Line) armati di buona volontà e fucili, oppure con l’avvelenamento di acque e cibi. Adesso che rappresentano il 2% della popolazione e la loro aspettativa di vita alla nascita è di una ventina d’anni inferiore a quella degli altri australiani, comprensibilmente, il primo ministro australiano Kevin Rudd, nel febbraio del 2008, ha presentato le sue profonde e sentite scuse alle popolazioni aborigene superstiti. Scuse che, con straordinaria signorilità, sono state accolte. Si descrivono, inoltre, con tardivo entusiasmo, persino il valore artistico e cromatico delle loro pitture rupestri, eseguite a sputo, ossia spruzzando con la bocca un paio di colori. Infine, si riproducono i loro tradizionali oggetti lignei: improbabili boomerang dipinti con gusto messicano e strumenti musicali, ossia rudimentali trombe e bastoncini, ancora in uso quando Antonio Stradivari da mezzo secolo era scomparso, da vendere ai turisti che non possono portarsi, come souvenir, un canguro oppure un koala a casa. Ma veniamo alla città che, troppo rapidamente, ho visitato. Secondo l’opinione comune, Sydney è la più antica, la più grande e la più bella città dell’Australia. Persino Cook giudicò quello della futura Sydney il più bel porto del mondo e il luogo migliore dove si potesse vivere, evitando però di dare il buon esempio. Forse per questo motivo, gli australiani gli hanno dedicato un dispendioso segno di riconoscenza a Melbourne. L’ultima dimora dei suoi genitori (Cook’s Cottage) fu smontata in Inghilterra nel 1934 e rimontata, mattone su mattone nei Fitzroy Gardens. Giardini, tuttavia, meno frequentati dai maggiormente estesi Royal Botanic Gardens. Cook, inoltre, forse per far dispetto a Banks, che si era innamorato di Botany Bay, all’immenso bacino, che unisce North Harbour con Middle Harbour e Sydney Harbour, impose il nome di Port Jackson, in onore di sir George Jackson, magistrato che era al seguito della spedizione. Banks, si prese la rivincita a babbo morto, ottenendo che il da lui protetto capitano William Bligh assumesse, nel 1806, la carica di Governatore del Nuovo Galles del Sud. Eppure, Bligh aveva già fornito prova del suo pessimo carattere e straordinarie capacità di orientamento in mare, una quindicina d’anni prima, raggiungendo l’Isola di Timor, in quarantasette giorni di navigazione, dopo il celebre ammutinamento del Bounty. Sulla terraferma, dove in alcune circostanze è più difficile navigare che in mezzo ai flutti, volle dimostrare di essere un rigido custode della legge nei confronti d’importanti rappresentanti della corona britannica, dediti ad affari poco limpidi.
In realtà, fece un errore madornale mettendo fuori legge l’uso del rum come merce di scambio, per eliminare l’alcolismo. Bisogna sapere, infatti, che il Corpo d’Armata inglese del Nuovo Galles del Sud aveva a disposizione notevoli quantità di rum il cui consumo, nonostante il prezzo elevato, era molto diffuso quale mezzo per sopportare condizioni di vita durissime. Sicché, i soldati britannici scambiavano il rum con altri beni o prestazioni lavorative ed erano conosciuti come Rum Corps. Costoro, toccati nei loro interessi, con baionette in canna nel 1808 attuarono la cosiddetta Ribellione del Rum, imprigionando Bligh, e controllarono la colonia sino al 1810. Bligh, alla fine, ottenne giustizia quando Sydney stava ormai crescendo impetuosamente per lo sviluppo di bacini carboniferi. Arrivati nel Sydney Harbour si ha l’esatta percezione delle dimensioni della metropoli, che si estende lungo venti chilometri di costa offrendo splendide insenature sabbiose, come Rose Bay o Bondi Beach, dove quasi tutto è vietato: fumare, usare aquiloni, portare animali, giocare al pallone, bere alcolici, collocare ombrelloni, pedalare in bicicletta, servirsi di bicchieri e bottiglie di vetro. Unico divieto mancante: non molestare gli squali che infestano le baie. Piacevoli sono i sobborghi, come Mosman, dove vivono i ricchi, lungo le cui vie si susseguono minuscoli bar, ristoranti, fruttivendoli, negozi di specialità alimentari, centri per massaggi, boutique e studi dentistici. Non meno gradevoli sono le abitazioni sorte sulle rive del Parramatta. Purtroppo, Sydney ci ha dispettosamente accolto con un cielo nuvoloso e una pioggia sottile, che il giorno successivo è diventata battente, forse per ricordarci che l’estate australe era finita e che la tradizionale sfilata gay del martedì grasso stava per iniziare. Appena posato il piede sul suolo della Sydney Cove, ho no-tato che il punto, dove Arthur Phillip, il 26 gennaio 1788, aveva piantato la bandiera inglese, non era segnalato nemmeno da un chiodo arrugginito. Invece, il ruscello Tank Stream, le cui fresche acque avevano convinto l’ammiraglio inglese a trascurare l’arida e inospitale Botany Bay, che diciassette anni prima a Banks era sembrata il paradiso terrestre, è un sotterraneo canale di scolo che da Hyde Park, il grande giardino pubblico più antico d’Australia, giunge sino al termine di Pitt Street. Insomma, ho ammirato lo sbocco di una fognatura. Non ho, ovviamente, visto, all’arrivo e nemmeno dopo, nessun discendente delle varie tribù aborigene insediate sulle rive della frastagliata baia, che acutamente si suppone vivessero di pesca e delle quali si conoscono appena i nomi.
Il centro città è vivace e moderno con agglomerati di grattacieli, architettonicamente senza capo né coda, ampi parchi di stile inglese e lunghissime vie che creano sgomento solo a guardarne la numerazione. L’interminabile Pitt Street, con parecchio sforzo, in un breve tratto potrebbe addirittura ricordare Las Ramblas di Barcellona. Cedendo alla mia indole temeraria, la Sydney Tower, principale attrattiva turistica della città, l’ho vista dalla strada che la costeggia. Il grattacielo, alto più di 300 metri, infatti, ospita soltanto un centro commerciale e l’immancabile ristorante, con la solita «vista a 360°» della baia, nel quale non mi sognavo nemmeno lontanamente di pranzare. Non ho visitato nemmeno l’immenso Acquario, con probabile costernazione dei pesci siluro, dei pinguini e di alcuni esemplari di ornitorinco. Invece, la cattedrale metropolitana di Saint Mary in pietra arenaria, completata nel 1928, non mi ha fatto cambiare parere sul funereo stile neogotico. Canguri e koala a parte, l’icona di Sydney è indubbiamente l’Opera House, inaugurata nel 1973 dopo oltre dieci anni di lavori, creatura avveniristica dell’architetto danese Jørn Utzon, che forse della tradizione lirica europea si era fatta un’opinione molto personale. Nelle fotografie, appare meravigliosa mentre, vista direttamente, sembra una manciata di gusci di cozze rimaste nel piatto dopo aver mangiato. L’ingresso dell’immenso teatro si può confondere con un accesso sotterraneo della metropolitana. Bar e foyer sono degni di una clinica per lungodegenti. Le sale per gli spettacoli sono moderne e molto pulite ma quella destinata alla lirica è stata ingiustamente criticata, per l’acustica inadeguata. La risonanza, in effetti, se non è pessima non è nemmeno eccellente per un raffinato melomane, ma la stravagante struttura accoglie molti più visitatori curiosi che amanti dell’opera lirica. Perciò, perché accanirsi su un dettaglio banale e si trascura la vocazione multietnica dell’enorme complesso, come la rappresentazione de Il Flauto Magico in salsa giapponese? Nondimeno, la singolarità della struttura è stata imitata. Infatti, a prima vista, il Tempio del Loto a Nuova Delhi, progettato nel 1976 dall’architetto persiano Fariborz Sahba, per quanto, come dice il suo nome, sia ispirato al fiore del loto, richiama palesemente l’Opera House. I gusci di cozze, però, sono disposti in maniera ordinata.
Quello di The Rocks è forse l’unico quartiere che ricorda il passato, quello dell’arrivo dei primi deportati, se non fosse infestato da negozietti che vendono orribili opali. È arduo, però, immaginare che di notte diventi un luogo spumeggiante, giacché alle cinque pomeridiane era triste come un camposanto e ho dovuto trangugiare in fretta una tazza di cioccolata, perché il locale stava per chiudere i battenti. Forse, nei tempi andati, con ex detenuti che fumavano come turchi ed erano remunerati con bottiglioni di rum, l’atmosfera doveva essere davvero incandescente. Invece, non mi sono addentrato in Chinatown perché mi sembrava una brutta copia dei bassifondi di Palermo. Devo confessare, inoltre, che mi sarei aspettato di vedere gioiellerie straboccanti di perle australiane. Da quello che ho adocchiato, se mi fossi fermato più a lungo, probabilmente la mia ricerca avrebbe fatto il paio con quella della frutta esotica nei Caraibi. Alla fine, ho deciso di recarmi ad ammirare le Blue Mountains per confrontare i loro colori con i riflessi rossastri delle nostre Dolomiti. Il mio crescente sciovinismo, diventato insopportabile anche a me stesso, è stato duramente castigato. Tutti i rilievi, oltre i duecento metri d’altezza, erano avvolti da una fitta nebbia. Così mi sono ritrovato a guardare l’ingresso di una miniera di carbone abbandonata, con la mente pervasa dal ricordo delle catacombe di santa Priscilla a Roma, e a fotografare canguri, la cui aria stupida era persino indisponente, e famiglie di koala in stato semicomatoso per la noia di sentirsi ripetere quanto fossero graziose.
MELBOURNE, 4 MARZO
Spesso definita ‘Capitale culturale dell’Australia’ e nominata, per tre volte, da The Economist ‘Città più vivibile del mondo’, Melbourne fu fondata nel marzo del 1835 dall’australiano di nascita John Batman, che due anni prima aveva acquistato circa 250 mila ettari di terra coltivabile da alcuni aborigeni, della tribù Kulin, che furono immediatamente ricompensati con 30 paia di coperte, 100 coltelli, 30 asce, 30 specchi, 50 forbici, 45 chili di farina, 200 fazzoletti e 6 canottiere. Fu loro promessa, inoltre, la fornitura annuale di 100 paia di coperte, 100 coltelli, 100 asce, 20 tagli di stoffa per abiti, 60 specchi, 50 forbici e 5 tonnellate di farina. Non bisogna credere, però, che gli indigeni fossero individui ingenui. Semplicemente, quali cacciatori-raccoglitori, non avevano il senso della proprietà privata. Per loro, vendere terreni era come vendere un tratto di mare. Sprovveduto, semmai, era l’acquirente che non poteva impedire ai cacciatori di cacciare e ai pescatori di pescare. Non tennero conto che la cosiddetta civilizzazione e la devastazione ambientale vanno purtroppo spesso a braccetto e non potevano immaginare che la caccia sarebbe diventata soprattutto una cosiddetta attività sportiva. Batman si era fatto precocemente una nomea quando, nel 1829, si era dedicato con ardore alla cattura e all’uccisione degli aborigeni in Tasmania, dimostrando straordinaria abilità nel difficile lavoro di snidarli dai cespugli dove si nascondevano. Impegno parecchio logorante e meritevole di doverosi passatempi. Svaghi, però, alquanto pericolosi, perché morirà, nemmeno quarantenne, alcolizzato e completamente distrutto dalla sifilide. Tuttavia, il suo sogno di fondare una città non si sarebbe realizzato se non avesse incontrato un affarista intelligente, il londinese John Pascoe Fawkner. I due compari di comune accordo, giacché l’insediamento era per così dire abusivo, non essendo stato autorizzato dalla Corona britannica, seguendo la moda dell’epoca, decisero di proclamare la nascita di Melbourne, onorando in tal modo il Primo Ministro d’allora, lord William Lamb 2° visconte di Melbourne, che nemmeno conoscevano. Forse, vollero dimostrare di non credere alle maldicenze che erano circolate sul suo conto quando, due anni prima, era stato coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale. Una vera stupidaggine, perché era stato soltanto anonimamente accusato d’intrattenere rapporti intimi con Caroline Norton, una donna sposata. Oppure, i due affaristi volevano ingraziarsi la diciottenne regina Vittoria appena ascesa al trono e che, forse, per il brillante visconte nutriva un debole.
Come che sia, nell’aprile del 1836, all’insediamento fu riconosciuto il rango di colonia e nel successivo mese di settembre William Lonsdale s’insediò a Melbourne quale rappresentante del Governatore del Galles del Sud. Forse Fawkner, per vie traverse, riuscì a forzare la mano al governo britannico, ma la creazione di un ordinamento politico fu resa necessaria anche dagli attriti tra europei e aborigeni. Contrasti di tutti i generi, dalle risse fino addirittura a un episodio di stupro di un’aborigena perpetrato da un commerciante britannico assatanato, che richiedevano l’esistenza di magistrati idonei a stabilire chi fossero i veri selvaggi. Mentre Batman si stava scavando la fossa con le proprie mani, Fawkner dimostrò di credere nel futuro di Melbourne, aprendo il primo hotel nella città e diventando editore, il 1° gennaio 1838, del Melbourne Advertiser. Nonostante numerose inimicizie, la sua reputazione crebbe a dismisura, tanto che il suo feretro, seguito da duecento carrozze, sfilò dinanzi a 15.000 persone. In poco più di trent’anni, aveva trasformato un luogo sperduto, dove era giunto con due vacche, due vitelli e due cavalli, in una città importante nell’export della lana e capace di reggere all’invasione dei cercatori d’oro. Melbourne è una città, ovviamente moderna, che da molto tempo tenta disperatamente di apparire più raffinata di Sydney, nonostante la sua baia piatta e dunque anonima. Ci è riuscita, parecchio a stento, ancorché lo sforzo richiesto non sia stato enorme. I turisti possono compiere persino una piccola ‘crociera’ sul fiume Yarra, che non assomiglia per nulla alla Senna. Anche se gli assomigliasse, però, non avrebbe intorno a sé Parigi. Quasi a voler confermare il mio pregiudizio, il battello sul quale mi sono imbarcato si è inizialmente diretto verso la foce. Così ho potuto ammirare un panorama di ca-pannoni, gru e container. Melbourne, però, è anche orgogliosa di edifici classificati tra i più brutti al mondo, come il Pixel Building o le costruzioni in Federation Square create all’insegna del cosiddetto ‘decostruttivismo’, ossia di un’architettura senza geometria. Anche il caos della non architettura ha i suoi ammiratori. Naturalmente, mi sono recato a vedere il Cook’s Cottage, molto meno interessante di una mostra di begonie nei circostanti Fitzroy Gardens. Durante il percorso sono stato informato che in Australia sarebbe stata scovata una felce di circa due milioni d’anni d’età, in un luogo mantenuto segretissimo. Mi è venuto in mente che, a Roma, ad alcuni turisti si è cercato di vendere persino il Colosseo. È facile intuire che non sono salito sulla terrazza panoramica dell’Eureka Tower, così chiamata in memoria della ribellione, avvenuta nel 1854, dei minatori che lavoravano nei giacimenti auriferi, rinunciando a una vista panoramica mozzafiato e alla conseguente furibonda crisi di vertigini. Così come mi sono privato del piacere di uno shopping al Queen Victoria Market, dove da oltre un secolo si vendono prodotti artigianali, gioielli, abiti, scarpe, profumi, frutta, verdura, polli, pesci, carne in scatola e dolciumi. La commistione di troppe merci, turisticamente allettante, mi è sembrata inquietante. Alla fine, ho deciso di visitare il Museo di Melbourne per conoscere qualcosa di più sugli aborigeni. A parte un paio di capanne ricostruite con il gusto pacchiano dei resort di grande lusso, ho visto cestini, piroghe, qualche monile e, esclusa la ruota, vari strumenti di legno, senza nemmeno una data di riferimento.
Si può comprendere che l’andatura dei canguri e la mancanza di altri grossi animali, utilizzabili per il traino di carri dotati di ruote, abbia nuociuto all’inventiva degli aborigeni e causato dunque il loro ritardo tecnologico di parecchi millenni nei sistemi di trasporto. Ma è difficile ritenere che sia stata colpa della fauna australiana l’inesistenza, tra gli aborigeni, non solo di un qualsiasi sistema di scrittura, prima dell’arrivo degli europei sull’immensa isola, ma anche di segni esteriori attestanti il rispetto per i defunti, patrimonio di tutte le grandi civiltà. Sicché, quando un archeologo australiano s’imbatte in una sepoltura aborigena, suppongo scorrano fiumi di champagne e il giorno che si dovesse scoprire una necropoli, sarebbe celebrato come festa nazionale. Insomma, ho riposto tutte le mie speranze di sapere di che diavolo si siano occupati gli aborigeni, per almeno 40 mila anni, in un libro che ho acquistato, pur temendo che le ricostruzioni storiche, sulla base della tradizione orale, consentano larghi margini all’immaginazione. Tanto per cominciare, ho tentato di capire l’elemento fondamentale della mitologia aborigena: il Dreamtime (Tempo dei Sogni), ovvero l’epoca antecedente la Creazione. Ho trovato l’argomento particolarmente difficile da afferrare, forse perché gli aborigeni l’hanno spiegato male, oppure perché la traduzione dei loro concetti è impossibile con le lingue moderne. Se ho ben capito il Tempo dei Sogni assomiglia, molto alla larga, all’Empireo (Mondo delle Idee) di Platone. Messa così, mi pare di non aver imparato proprio niente. Sennonché, per gli aborigeni, tale credenza implicherebbe il dovere di non modificare l’ambiente naturale. Giacché non rimpiango di essere rimasto all’età della pietra, con tutto il rispetto per l’interpretazione aborigena del mondo sensibile, ho maturato soltanto il preconcetto che l’archeologia, in Australia, sia un’impresa disperata.
PERTH, 8 MARZO
L’olandese Willem de Vlamingh, al comando di tre vascelli, nel 1696 partì da Amsterdam per tracciare la carta nautica di una parte di quel territorio, chiamato New Holland da Tasman, che è la costa occidentale dell’Australia e anche per stabilire la sorte del vascello Ridderschap van Holland, misteriosamente scomparso nel 1694. In breve, il 26 dicembre 1696, de Vlamingh si ancorò al largo di un’isola, che oggi dagli abitanti di Perth è ritenuta un paradiso terrestre, sulla quale probabilmente non pose nemmeno piede, perché la ritenne infestata da enormi ratti e la battezzò, profondamente disgustato, Rottnest (Nido di ratti). In realtà, erano quokka, piccoli marsupiali, pesanti da 3 a 5 chili, più goffi dei canguri e che, con gran dolore degli animalisti, sono in via d’estinzione. In seguito, il 5 gennaio 1697, sbarcò nei pressi dell’attuale Cottesloe Beach e cinque giorni dopo, marciando verso est, incontrò un fiume frequentato da numerosi cigni (swans) neri che chiamò Swan. Nella zona incontrò un gruppo di aborigeni della tribù Noongar, cui chiese informazioni sul vascello svanito nel nulla. Com’era prevedibile, non ottenne notizie, ammesso che le sue domande siano state comprese. Infine, il 4 febbraio 1697 giunse all’Isola Dirk Hartog, dove sostituì la targa in peltro posta dall’esploratore compatriota con una nuova e trasportò il cimelio sino ad Amsterdam, al termine di un lungo viaggio inconcludente. Sicché, gli aborigeni australiani continuarono a vivere felici e contenti, per quasi un secolo e mezzo, prima dell’arrivo dei pionieri. Perth, infatti, fu fondata il 12 agosto 1829 con una curiosa cerimonia, illustrata da un dipinto scaturito dalla fantasia di George Pitt Morrison. Infatti, mancando una prima grossa pietra da posare, fu deciso di commemorare l’evento abbattendo un albero, quale segno di rispetto per l’ambiente. Sorprende che i cigni neri non siano finiti allo spiedo. Non solo. Il primo colpo d’accetta fu assestato da una fragile donna vestita di bianco, la ventitreenne Helena Dance, quasi a significare che le devastazioni sarebbero avvenute con femminea delicatezza. Scena davvero idilliaca, dinanzi agli occhi compiaciuti di James Stirling e dell’appena arrivato John Septimus Roe, rispettivamente Governatore e Sovrintendente dell’Australia Occidentale, oltre che di un gruppetto d’eleganti gentiluomini tra i quali il capitano Charles Fremantle — figlio di un ammiraglio e accusato, tre anni prima, di aver stuprato una quindicenne — sprizzava gioia da tutti i pori, essendo in procinto di partire per Ceylon il successivo 25 agosto. Nel dipinto, costato all’autore diciotto mesi di ricerche storiche, di coraggiosi pionieri non si vede nemmeno l’ombra. Sviluppatasi lungo i fiumi Swan e Cannig, la colonia britannica vivacchiò modestamente finché, nel 1849, divenne una splendida sede per i condannati ai lavori forzati. Difatti, con l’arrivo di oltre novemila detenuti in sedici anni, l’impulso edilizio fu davvero notevole. Ma la dinamica abitativa e quella demografica divennero travolgenti quando, nel 1880, nei suoi dintorni furono rinvenuti giacimenti d’oro. E anche se la febbre dell’oro durò un decennio, Perth non fu abbandonata pur essendo in capo al mondo.
Contrariamente a Sydney e a Melbourne, il porto di Fremantle ci ha accolto senza una goccia di pioggia, ma con dense nubi che la promettevano. Forse, santa Lucia ha continuato a proteggermi, tutelandomi dagli effetti nocivi del buco nell’ozono che, in Australia, causerebbe una montagna di tumori maligni della pelle. Dalla cittadina di Fremantle, situata alla foce del fiume Swan, il cui edificio più antico è la Round House (carcere funzionante sino al 1991), essendo nata come porto, sarebbe fuori luogo pretendere che non sia quello che effettivamente è. Lungo la via centrale ci sono moltissimi bar, segno evidente che mancano altri divertimenti. L’affollatissimo mercato coperto ricorda il Misir Ҫarşisi di Istanbul, con qualche differenza. Nell’antico bazar turco, si vendono colorate e odorose spezie di ogni genere, profumi orientali, stoffe pregiate e caviale iraniano. In quello di Fremantle si trovano merci inacquistabili e cibi disgustosi. Perth, invece, è una mediocre città moderna, con qualche edificio antico, il cui ombelico, nel centro pedonale, è la Lon-don Court, un complesso edilizio, realizzato nel 1937 in stile Tudor-Tirolese, con negozi creati apposta per i turisti. Moderno ma — più che insignificante — scalcinato, è il quartiere cinese. Nel grande Parco Botanico, svetta un agonizzante baobab di 350 milioni di anni (se ci si crede), la cui chioma ha subito un taglio militare, circondato da un cancello per timore che se ne vada altrove. Come deve essere successo con i cigni neri, dei quali non ho visto nemmeno una piuma. Per descrivere tutto il resto, sarebbe sciocco sprecare tempo, carta e inchiostro. In conclusione, forse Janszoon, Hartog, Tasman e de Vlaming non apprezzarono adeguatamente l’Australia, anche perché era quasi completamente deserta. Oggi, con le sue metropoli, probabilmente non è migliorata, giacché le bellezze naturali possono essere deturpate con l’idea di renderle ‘vivibili’.
SINGAPORE, 14-16 MARZO
Singapore, città-stato separata dalla penisola di Malacca dallo Stretto di Johor, ossia da un fosso, è considerata uno dei luoghi più cosmopoliti del mondo. Un cosmopolitismo un po’ curioso, giacché i 4/5 degli abitanti che hanno la cittadinanza di Singapore sono per il 74 o 77% di lingua cinese, mentre l’idioma ufficiale è il malese. In sostanza, il 90% della popolazione è cinese oppure malese. Statistiche inutili, poiché Singapore è considerata l’emblema del libero mercato e del consumismo. Perciò, non è difficile intuire, parafrasando l’imperatore Vespasiano, che non avendo il denaro etnie, Singapore sia la capitale del capitalismo materialista e di un mondo schizofrenico. Un luogo dove si fabbricano oggetti meccanici destinati a resistere sempre meno, per dilatarne i consumi, mentre si creano cibi sintetici destinati a durare nei secoli. Cinismo del destino nei confronti di sir Thomas Stamford Raffles che, nel 1819, pensò di aver scippato Singapore alla Malesia, legandola alla corona britannica e alle usanze tradizionali anglosassoni, per sempre. Singapore è famosa per l’enorme quantità e varietà di merci in vendita: sete indiane grezze o ricamate, macchine fotografiche e cineprese, ceramiche e porcellane cinesi autentiche o contraffatte, perle, gioielli, pietre preziose, orchidee fresche immerse in un bagno d’oro, giade, bronzi, servizi d’argento inglesi, piante e animali fossili, spezie e profumi provenienti (dicono) da tutto il pianeta, rimedi dell’antica medicina cinese, kriss malesi, lacche birmane e anche carne umana, per uso non alimentare, palesemente o in forma truccata, come nel resto del mondo. Basta ridurre del 50 o 70% quest’immagine fiabesca e si avrà la visione reale. Nondimeno, ben si comprende perché molti turisti siano disposti a rischiare l’infarto, affrontando temperature e umidità da bagno turco, per acquistare a prezzi convenienti tutto il superfluo che si possono permettere. Tranne che non trascorrano le giornate nel gran numero di casinò, disseminati nella zona di Marina Bay, dilapidando i propri averi senza comprare niente. Eppure, in questa città proiettata verso il futuro, esistono consuetudini del passato, come la fustigazione giudiziaria, scolastica e genitoriale. Bisogna rimarcare, però, che la fustigazione giudiziaria è praticata secondo norme minuziose per quanto concerne il controllo medico, la lunghezza (1,2 metri) e lo spessore (1,27 centimetri) della frusta che deve essere trattata con sostanze antisettiche, per evitare infezioni cutanee ai condannati. Le più sottili fruste domestiche, invece, possono essere di colori diversi, costano poco e registrano un picco di vendite nel periodo degli esami scolastici. Altrettanta severità si applica contro l’importazione di sostanze nocive, con l’imposizione di tasse doganali su alcolici e tabacchi (circa 20 centesimi di euro per ogni litro di liquore e 17 centesimi per ciascuna sigaretta) e con il divieto assoluto di introdurre nel Paese le temibili gomme da masticare, pere evitare il pericolo che si appiccichino alle suole.
La mia prima ricerca in città, con un caldo umido per niente letale, è stata odontoiatrica nel Buddha Tooth Relic Temple, in Chinatown, dove sarebbe gelosamente custodito, come sacra reliquia, un dente di Gautama Buddha. Entrato disinvoltamente nel tempio, perché è curiosamente consentito accedervi con le scarpe ai piedi, ho scoperto che, per un non buddista, è impossibile sapere se si tratta di un incisivo, di un canino o di un molare e, soprattutto, dove diavolo sia nascosto. L’interno del tempio è uno scintillio d’oro di almeno una decina di migliaia di statue e statuette non dell’asceta nepalese, ossia del Buddha storico conosciutissimo, ma dei Buddha. Altrimenti esisterebbe un culto della personalità da far rivoltare Mao Tse-tung nella tomba. Infatti, senza approfondire la questione, giacché il buddismo, incastrato nel politeismo induista e diviso almeno in tre correnti, accanto a una ventina di Buddha umani, esiste anche una nutrita pattuglia di Buddha ‘cosmici’ che, a parte Bhaiṣajyaguru, ossia il Buddha della medicina, non ho ben capito a che cosa servano. Devo, però, ammettere che non è il mio unico buco nero. A quanto ho letto, Gautama affermava l’esistenza di ‘rinascite’ successive, escludendo la ‘reincarnazione’. La differenza è troppo sottile per essere universalmente compresa, tanto è vero che, quando la più alta autorità teocratica buddista tibetana — il Dalai Lama — muore, vengono svolte accurate indagini per identificare la sua reincarnazione in un bimbo nato, incomprensibilmente, prima della sua scomparsa. Ho trovato conforto, però, dopo aver appurato che, secondo alcuni studiosi, il buddismo sarebbe una religione ‘atea’. Consolante antinomia per gli ignoranti. In ogni caso, Singapore non mi è parsa il luogo adatto per raggiungere il nirvana, ammesso che sia possibile.
Metafisica a parte, nella disperata impresa di collocare storicamente Gautama, si sono impegnati studiosi di tutte le razze e di tutte le fedi, con un solo risultato certo: sarebbe vissuto tra il VI a.C. e il IV secolo a.C. Insomma, le possibili date di nascita e di morte sono comprese in un arco temporale superiore al secolo e mezzo. Curiosamente, però, gli storici concordano che morì ottantenne e che, dopo essere stato avvolto in cinquecento pezze di cotone e immerso per sette giorni in un pentolone pieno d’olio, fu cremato. Consapevole che la dottrina buddista è parecchio complicata, addirittura troppo se si desidera raggiungere il nirvana, avevo supposto che nel santuario avrei trovato fedeli in atteggiamento ascetico. Invece, benché l’interno del tempio, nonostante l’affluenza, fosse abbastanza silenzioso, le persone presenti conversavano amabilmente, quasi fossero in un bar, mentre le vetrinette di souvenir in vendita non creavano un’atmosfera mistica e tantomeno propedeutica alla ‘illumi-nazione’. Ciò ha ulteriormente rafforzato la mia convinzione che del buddismo, al cui confronto la teologia cristiana è roba da scuola elementare e la Summa di Tommaso d’Aquino l’opera di un principiante, non avevo afferrato e non afferrerò mai niente. L’apprendere che in India, dove il buddismo è nato, i suoi seguaci sono meno dell’1%, però, ha ridotto la mia pena. Parecchio singolare è il non distante Sri Mariamman Temple, cattedrale della corrente religiosa induista Agama, denominata anche tantrismo, edificato secondo i canoni estetici dell’architettura dravidica in chiave moderna. Devo confessare che, prima di arrivare a Singapore, possedevo vaghe nozioni sul tantrismo e sull’architettura dravidica, mentre della religione Agama non sapevo nemmeno l’esistenza. Adesso, che sono più informato, mi sono convinto che anche del politeismo induista, delle sue pratiche religiose, dei suoi testi sacri, della sua cosmogonia e dei suoi sistemi filosofici non capirò mai un accidente. Eppure, aver letto che i tre legittimi obiettivi ‘mondani’ degli induisti sono la ricchezza materiale, la giustizia e il pieno appagamento dei desideri sessuali, mi aveva invogliato ad approfondire le mie conoscenze in merito. Sennonché, dopo aver appreso che il fine ultimo della vita consiste nella liberazione dalle catene del nascere-morire, ho avuto la sensazione che mi sarei immerso in un’atmosfera d’aria fritta. Perciò, ho deciso di sopravvivere nella mia beata ignoranza, a costo di accrescere il mio debito karmico, con conseguenti miserabili rinascite in entità corporee disgustose, senza meritare che sia messa fine all’eterno ciclo del samsara.
Ovviamente, come molti altri, nutro un profondo scetticismo nei confronti della dottrina della metempsicosi, anche se il Credo cattolico, con la Resurrezione della Carne nell’apocalittico finale, promette una reincarnazione collettiva. In breve, ho soltanto capito che parlare d’induismo sarebbe come discorrere di giordanismo, intendendo con questo termine l’insieme delle diverse correnti religiose cristiane ed ebraiche che ebbe origine sulle rive del fiume Giordano. Sarebbe, insomma, come sprofondare in due teologiche insalate russe. Il tempio, con edifici annessi, dedicato a Mariamman, dea della fertilità e capace di guarire malattie come il morbillo, la varicella e l’herpes zoster, è difficile da descrivere ma, sintetizzando l’immagine, vincerebbe il primo premio nelle sfilate carnevalizie di Viareggio, per il policromo groviglio delle divinità rappresentate, talune con seni prorompenti e natiche seducenti. Il baffuto dio Iravan, dagli occhi stralunati, come se fosse affetto da ipertiroidismo, le orecchie enormi, i canini vampireschi, con un cobra che gli spunta dalla corona conica, ha una piccola cappella riservata. Onore dovuto perché, oltre a rendere le donne miracolosamente fertili, è il patrono dei transgender, con un costante aumento del numero dei devoti. Tuttavia, contrariamente al Buddha Tooth Relic Temple, non sembra una rivendita di souvenir e non è consentito accedervi con le scarpe ai piedi. Mentre mi aggiravo attonito nel tempio, con il naso in aria, è iniziata una cerimonia religiosa fulminea, ossia un veloce corteo al seguito di una statuetta dorata di Mariamman, giunta sul luogo sopra un sontuoso calesse, pittoresco come un car-retto siciliano di gelato, e sul quale è stata devotamente ricollocata, rischiando di essere travolta dal traffico caotico.
Il resto di Chinatown è architettonicamente gradevole, per l’esistenza di numerose abitazioni in stile coloniale. Sennonché, non essendo sufficientemente americanizzata, è parecchio più lercia della Chinatown di San Francisco. Giacché la pulizia nel quartiere Little India è un’astrazione, si può dubitare che il divieto d’importazione delle gomme da masticare sia una norma igienicamente sufficiente. Naturalmente, l’edificio più ammirato è il Marina Bay Sands, ossia tre grattacieli sormontati da una piattaforma a forma di scafo, dove si può provare il sublime piacere di nuotare in una piscina a 200 metri d’altezza. Tuttavia, nel 2012, sono stati i Winter Gardens di Singapore ha ottenere la qualifica di edificio più bello del mondo, con probabile muto compiacimento delle sue pensionanti innaffiate con amore. L’ArtScience Museum, invece, assomiglia a un fiore di loto oppure a mezza arancia affettata. Il trionfo del kitsch, però, si può vedere sull’Isola di Sentosa, dove svetta ruggente e monumentale The Merlion, al cui confronto il Leone Alato di Venezia, con la sua aria casalinga, sembra un micione pronto a fare le fusa. Ho avuto la fortuna di visitare l’isolotto sotto una pioggia torrenziale e ho apprezzato le eleganti tettoie che consentono di passeggiare senza bagnarsi. Al contrario di Pompei dove, in situazioni analoghe, si cammina con l’acqua fino alle caviglie. Il tempo è stato invece più clemente, mentre percorrevo il National Orchid Garden che ospita, a quanto si dice, più di 3.000 specie di orchidee. Sarà stata colpa della stagione, ma di differenti piante fiorite ne ho osservate, al massimo, cinquanta e pochissime veramente belle, come quelle che si possono acquistare dai migliori fiorai in tutte le metropoli. Infine, le orchidee ricoperte d’oro, in vendita, non erano fresche bensì di plastica.
(4 – continua)