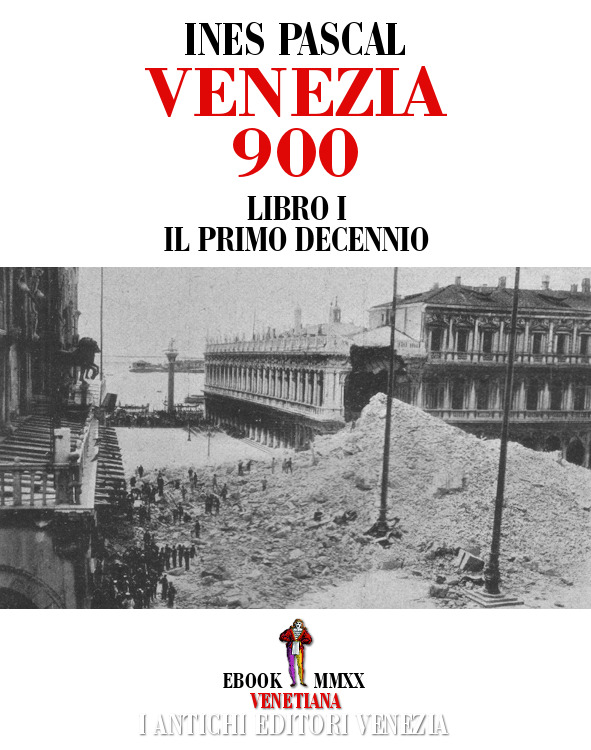Cometa
cometa
Halley, de Vico e tanti altri,
che con il loro scrutare
hanno allargato i confini
del cielo.
PREMESSA
Questa storia è realmente accaduta, solo un poco più seria, in un’isola lontana dall’altra parte del mondo, non troppi decenni or sono. Ciò non toglie che possa accadere domani, ed è garanzia che in futuro accadrà ancora, chissà dove.
PROLOGO
Un’immane tragedia si profila
Se quella mattina il contino Guglielmo si fosse alzato come al suo solito all’alba, avrebbe veduto dal balcone del torrione uno spettacolo a dir poco singolare, magari additandone i protagonisti all’attonita e stupita Eberarda, quadrumane bianco e rosa che suo zio Venceslao aveva riportato dall’Africa Nera e lontana, sua unica amica a parte il gatto Gastone bigio acciambellato ai piedi del letto, e il corvo nero appostato in cima al cipresso in fondo al giardino.
Nella campagna appena illuminata dalla chiaria dell’alba nuvolosa, correva sull’argine, sferragliando nella nebbia novembrina, un ciclista tutto imbacuccato di stracci neri, ansimante per lo sforzo, incurante della velocità che lo portava a rischiare, in funamboliche sterzate, cadute rovinose dalla ghiaia grigia della stradina soprelevata all’acqua nera e immota del canale navigabile sottostante.
Lanciava a tratti, il ciclista, degli spaventevoli ululati, grida frammiste di dolore e di paura, lamenti incomprensibili e tutta una congerie terrificante di suoni inarticolati che pareva da lontano un a-o-u tormentoso da baratro infernale. Aiutato nell’urgenza dal diabolico occhieggiare giallo e idiota del fanalino anteriore della bicicletta, ancora necessariamente acceso nel diffuso grigiore del crepuscolo.
Gli correva incontro, brandendo alta nella destra ossuta la ramazza di saggina che per l’emozione non aveva potuto posare, la vetusta Giustina, curva e acida vecchia fattrice dei conti Loredan, immutabile muffito orrore per cui Guglielmo nutriva ancora lo stesso timorato ribrezzo della sua infanzia. E strideva, la vetusta Giustina, un interrogativo acuto che fendeva la nebbia e superava l’alto muro di cinta della villa secentesca, giungendo affiochito fin quasi nella stanza del contino, dove stuzzicò appena, per un istante, l’orecchio attento e mobile del micio bigio. Strideva un urlio secco e breve che si perdeva per i campi arati ancor neri della notte, cui il ciclista rispondeva con quanto fiato aveva in corpo, alterando a dismisura il suo guaire oscuro.
Solo quando fu finalmente caduto tra il terriccio e le canne umide di guazza, travolto dalle finte e dagli scarti dell’antica arpia, le ruote del velocipede a girare liberamente nel vuoto umido del mattino campagnolo, rosso in volto sotto lo sguardo incolore e ottuso dell’annosa Giustina, il ciclista articolò ritrovando la favella, tra un ansito e un gemito:
«La fine, la fine, la fine. È la fine. È la fine del mondo!»
Il corvo, nero sul cielo cenerino, gracchiò sulle loro teste. Beffardo.
Il contino Guglielmo schiuse un occhio, osservò la luce del giorno filtrare attraverso i pesanti tendaggi damascati e si girò dall’altra parte, discacciando dal letto Eberarda e il gatto Gastone, contento di aver interrotto con un pigro sonno destinato a durare fino a mezzogiorno, almeno per una vota, la sua monotona vita di giovine signore in esilio volontario dal mondo intero.
CAPITOLO PRIMO
Nel quale s’apprende circa l’oscura minaccia
che grava sul destino dell’intera umanità
«La chioma della cometa, ché da tale essa prende il nome: kometes, chiomata, come anche ne è ornata, còmita, e che pure ne è accompagnata, come appunto il comes romano accompagnava i legati imperiali, ché similmente ad un sidereo ambasciatore si potrebbe comparare tale prodigio stellare, la chioma della cometa…» concluse il chiarissimo professor Marco Tullio de Caliginis, eccelso luminare nonché preside del liceo ginnasio di Verdognola, professore esimio di lettere antiche, filologia germanica e botanica comparata, corrispondente locale de La Gazzetta Illustrata, non di meno poeta epico, elegiaco e gnomico, «…la chioma della cometa, dicevo, altro non è che calorico puro in dispersione nell’etere sidereo, che si distacca dal nucleo del bolide celeste in virtù dell’elevata velocità della cometa stessa e per lo sfregamento inevitabilmente derivante nel passaggio traverso l’etere stesso che empie gli immensi spazi di tra le stelle e che, per quanto impalpabile e direi quasi immateriale esso sia, a tali velocità diviene come corpo solido, al modo in cui vediamo d’agosto le meteore tracciare nel cielo notturno scie di fuoco per lo sfregarsi con la medesima aria che noi stessi con tanta facilità quotidianamente inspiriamo ed espiriamo quasi senza bada alcuna. Onde temo che…», e nel dire il professor esimio de Caliginis si accomodò sul naso lucido e curvo come becco gli occhiali dalla montatura dorata, scrutando gli astanti durante la breve, sapientissima, pausa, «…onde temo che il passaggio della cometa nella nostra atmosfera, se non si tradurrà detto passaggio in orrida collisione peraltro sempre possibile, incendierà come unica favilla tutta l’atmosfera terrestre, in un’unica immane fiammata che percorrerà in un attimo tutto il globo terracqueo da parte a parte. Estinguendo per combustione o conseguente asfissia, ogni forma di vita così come noi la conosciamo».
Pausa. Di fremente silenzio.
«Ecco! Ecco! Ve l’avo disto io», si levò, fra l’assemblea attonita della sala cinquecentesca del Circolo Culturale di Verdognola inconsuetamente gremita, il ciclista Marietto, telegrafista nella vicina Sertagna, mattutino latore della ferale notizia alla cittadinanza intera, «E viantri, cà no me criivi, ignoranti!».
Il silenzio avvolse la sala, si distese sui volti ebeti di secolare sottomissione al volgere della Fortuna, delle Stagioni, dei Potenti, dei verdognolesi interamente convenuti. Si stampò come cera molle tra gli occhi cerulei e i nasi lunghi ereditati secoli e secoli prima dai barbari traci, allungo le mutrie del farmacista Aristide Salveni e del protoveterinario Fermo Castagni, inumidì il ciglio della maestrina Achiropita Sanna, legò lingua e palato dell’avvocato Regeni, annodò i pensieri del notaio Scipione Vincisguerra, ronzò nella chiocciola del perito meccanico Pino Renzi, colpì in pieno volto come uno schiaffo il barbiere Salvatore D’Arrigò, slargandogli la fronte fra le iridi e i capelli ricci corti ispidi fitti neri come l’inferno.
La Terra. La terra tutt’intera avvolta d’una subita fiamma. Violentissima. E poi più niente. Mai più niente. Per sempre.
E la Morte che vola silenziosa fra il nero delle stelle. Un tocco solo delle sue gelide dita e non ci sarebbe stato più, in nessun angolo del pianeta, tondo o piatto che fosse com’ancora dubitava l’antica Giustina, neanche un briciolo d’aria da respirare. Neanche per gli Esquimesi che vivono a testa in giù al Polo Sud, neanche per i Cinesi impegnati a cucinare cagnolini da latte farciti di formiche e pelle fritta di serpente, neanche per gli Indiani intenti a trafiggersi con canne di bambù lasciate crescere poco a poco. Non più neanche un piccolo piccolo piccolo atomo d’ossigeno, meditò il professor de Caliginis. Non più nemmeno e mai un goccio d’aria.
E mancavano solo due giorni.
«Et vidi stellam de caelo che cadesse in terra, et data est ea chiave putei abyssi; et aprit puteum abyssi, et sale fumo putei, sicut fumo de fornaci magna; et obscuratus est sole et aere de fumo putei!» Tuonò fra le arcate rinascimentali la voce possente tuonante di don Rosalio, parroco di Verdognola da oltre tre decenni.
Qualcuno, il barbiere, alzò gli occhi al cielo con ostentata sopportazione, la Giustina sgranò il rosario, gli altri, quasi tutti, ottusi alla lettera, ma non al senso, chinarono il capo come gregge dolce e remissivo.
CAPITOLO SECONDO
Natura e sostanza di una grande idea,
ovvero come il connubio dell’Anima con l’Economia
porta alla Salvazione dell’Umanità
La mattina della vigilia del giorno della Fine del Mondo, il cavalier Rosmindo Carnemolla, proprietario dell’unica, solida, grande azienda del circondario di Verdognola, la «Fu Carnemolla cav. Guido e Figlio, lavorati in gomma sintetica, caucciù e pneumatici per biciclette e da lavoro» come proclamava all’universo mondo la chilometrica insegna rosso e oro sul frontale della fabbrica, sotto la ridente e paciosa effigie del fondatore, il fu cavalier Guido, traversava fra animati pensieri la via maestra della cittadina, appoggiandosi al pomello d’avorio del bastone da passeggio, necessario aiuto alle piccole e secche gambette nel sostenere il tamburo teso e possente dell’epa e del torace, amorevolmente fasciati dal vellutino verde del gilè.
Pensava, il cavalier Rosmindo, alle non immense ma laute ricchezze che producono la lavorazione e il commercio della gomma e del caucciù, che così previdentemente intraprese il pur pionieristico padre, cavalier Guido, e che così oculatamente continuavano le sue piccole paffute attente mani. Pensava, il Rosmindo cav. Carnemolla, ai suoi quindici operai, ai tre impiegati, al rappresentante impomatato e dalla gengiva rosata, obbligato, pena licenziamento, a mai pronunciare «pneumatichi» e, ancor meno, ad intraprendere commercio carnale con figlie, mogli, segretarie e affini dei clienti presenti, possibili e futuri. Pensava alla Alessia, la giovane segretaria svolazzante, dall’orrido accento di campagna, ma con i fianchi, e gli occhi, gli occhi, belli come il peccato. E pensava, poggiandosi sul pomello d’avorio, pensava, con il realismo terra terra gli era sempre stato campagno, che tanto bendidio era destinato, senza appello o mora, a tramutarsi in polvere nerastra e untuosa, uniforme e informe, nel breve volgere di un respiro, o, per meglio dire, a dispregio del fato iniquo, nella durata d’una scorreggia; e tutto insieme, e, quel che è peggio, ogni cosa prima della sua naturale e necessaria transustanziazione in pulve. Passi, opinava, per quell’ippopotamo sfrontatamente intrufolatosi nel coniugal talamo con la frode e con l’inganno trentacinque anni prima. Passi per la progenie demente ed esangue che se n’era procreata. Passi pure per quei quindici operai anarchici, comunisti, fedifraghi, sobillatori, scioperati e ingrati. Passi per Verdognola: altro che cometa incendiaria ci sarebbe voluta. Ma per la fabbrica, per le odorose balle di caucciù, per l’effigie di suo padre, anche per le gengive del rappresentante, e, in fondo, per le fresche mani di Alessia, una soluzione, come quella volta della crisi mondiale dell’hevea, una soluzione bisognava trovarla.
A tutto questo pensava il Rosmindo Carnemolla, cavaliere emerito del lavoro, mentre si tormentava il mostacchio con la destra, e una pioggerellina lieve lieve, come di marzo, eppur s’era di novembre, scendeva dal cielo grigio, e quasi non s’accorgeva dei saluti e della pioggia.
Fu il barbiere D’Arrigò, con quel suo accento caldo e angoloso del meridione versato a profusione nel lontano dialetto del Nord, con tutto quel pelo nero e riccio ben accomodato anche nei buchi delle orecchie, a distoglierlo dalle sue affannose elucubrazioni: «Eccellenza, non basterebbe neppure se chiovesse: sarà un fuoco, chille, che son di quelli che non si spengheno».
«Eggià d’Arrigò, son fuochi, quelli, che non si spengono» biascicò, stritolò tra il baffo, il labbro e i denti il cinquantasettenne cavaliere, «e non servirebbe nemmeno rintanarsi sotto in cantina. Fuori non si potrà mica respirare la polvere».
«E l’aria, l’aria» parve assopirsi un momento, dondolando l’epa sul bastone, alla ricerca di un qualcosa effimero e sfuggente, «l’aria non sta mica ferma». Abbrancò il nulla a un palmo dal naso lucido del barbiere D’Arrigò, sventagliando la manona nell’aria umida della barbieria.
«Ma per voi, eccellenza, per voi» e D’Arrigò prese il gomito del cavalier Carnemolla, avvicinandogli il viso all’orecchio, aromatizzandolo di lozione e sapone da barba al mentolo, lavanda e alito agliato di peperonata forte e speziata, «Per voi, cavaliè, l’aria non canosce misteri, altro che in pugno, la tenete».
«E ho pensato, se permettete, che se potreste vendermi qualcuno dei vostri pneumatichi… al vostro prezzo, naturalmente…»
Ecco, ecco, ecco quello che si rintanava nelle circonvoluzioni cerebrali del cavalier Rosmindo che più che lui lo cercava, più s’affondava nel fondo dei pensieri, come un brillante lucente minuscolo smeraldo di speranza che scenda nel fondo fangoso e infinito d’uno stagno e più si posa, più scende nella mota. Ecco. Infine, da una mente abituata al lucido perfetto taglio del rasoio, al profumo di sapone, ecco l’idea. Alessia e le sue mani, lui, se stesso, il cavalier Carnemolla, la fabbrica, anche gli operai, gli impiegati, e i clienti, tutta Verdognola, anche le gengive, anche tutto il mondo se possibile, tutta l’umanità bipede e cornuta, tutti salvati dall’aria pompata, costretta, conservata e custodita, pro humanitatis utilitate et salute e dietro naturale, dovuto e necessario compenso, dalla premiata ditta «Fu Guido cavalier Carnemolla e figlio» nei suoi immarcescibili, elasticissimi, collaudatissimi pneumatici e camere d’aria, prodotti con latici e gomme sintetiche di prima qualità, controllati fin dall’origine.
Profitti immensi, imperitura commossa doverosa memoria ai posteri, qualifica di «salvatore dell’Umanità», più in piccolo, ma molto più in concreto di altra concorrenza, che usa rappresentanti alla don Rosalio, tutto fumo e niente arrosto. Gloria, danaro e fama, da un’umanità trasformata a vivere respirando dalle gomme carnemolla, fino a che gli oceani e la terra, in eterna compassione, non avessero restituito l’aria tolta con maleficio e furore dalla malsana cometa.
C’era un santo, pensava il cavaliere, un santo potente. Il buon geodeta Carlo Maria de la Condamine, partito secoli or sono a misurar archi di meridiani in Perù, e che fece all’uomo il miracolo più grande: il caucciù. E lui, Carnemolla Rosmindo, fu Guido, traverso l’incarnazione momentanea del santo in figura di barbiere meridionale, ne era divenuto servo devoto, rappresentante plenipotenziario ed esclusivo, custode ed artefice ad un tempo del dono miracoloso. E vide anche, con l’occhio febbrile della mente, la pietosa scena in cui, tra le altissime e verdi montagne del lontano Perù, Carlo Maria, per il bene del genere umano, mutò il rosso suo sangue che fluiva dalle piaghe del suo martirio nel bianco, puro, immacolato e gentile latice di caucciù.
CAPITOLO TERZO
Si apprestano risolutivi necessari rimedi
Più che una persona umana, come ancora racconta l’Osvaldo, capo presse e perito miscelatore, il cavalier Rosmindo fu una furia, uno scatenamento della natura, un tifone, un tornado, un accumulo di forza immane e primeva, vorticante su se stessa, devastante e irrefrenabile. Entrò nel reparto mescole, ovverossia tutta l’officina, ululando a destra e a manca ordini secchi e massicci, come belva che si scrolla di dosso ceppi e catene, scagliandoli all’intorno infranti e contorti, torcendosi come un dannato fra le fiamme del fuoco eterno. Urlava la sua voce da baritono tendente al basso come capitano di nave travolta dal delirio dell’Oceano, cui ogni ordine perduto è più letale dell’onda che batte e del vento che spezza alberi e sartiame: «Olindo, Giulio e Vitale, fuori tutto dal magazzino!» «Egidio, Basilio, Nero e Aligi, più forza alla mastica!» «Osvaldo, controlli lo solfo, ché ce ne sia bastanza!»
E la caldaia sbuffava il suo vapore, il clangore dei cilindri aumentava ritmo e intensità, i muscoli degli uomini si gonfiavano sotto le canotte a coste. E l’aria si riempiva di calore, dell’odore delle mescole e dello zolfo, del sudore e delle occhiate storte dei quindici operai, delle grida del cavaliere, di bestemmie, di ansiti e respiri, del ritmico pulsare delle macchine.
«Camere, camere, camere, solo camere!» sbraitava Carnemolla all’indirizzo dell’Osvaldo, «camere d’aria per un futuro senz’aria. Misura unica, quella grande!»
E presto presto presto, urlava, portandosi a spasso sulle sue gambette secche e storte: abbiamo solo tutt’oggi e questa notte, e domani salveremo la vita il mondo e la cassa.
Intanto, là, su su su, distante e veloce, nuda e scintillante, fastosa nella sua eterea argentata chioma che già s’allungava nella coda lunga milioni e milioni di chilometri, la cometa scendeva verso il sole, ignara di Verdognola e delle gomme, passando tra stella e stella, scansando satelliti e pianeti, nell’ennesima, lunghissima, girante traiettoria. Fremeva a tratti nella sua corsa astrale, come se il vento solare le scompigliasse la chioma con la rude dolcezza degli innamorati. Presentiva, forse, il passaggio troppo vicino, troppo carnale, con quel tiepido, denso, popolato, pianeta verde e azzurro, umido, ributtante meschino intruso nella sua orbita di adamantina e pura perfezione. Presentiva e fremeva, scendendo senza un suono a girare il sole, suo amato, suo desiato ultimo abbraccio.
Ma il Rosmindo urlava e sudava fra i vapori, con il sole già al tramonto e il gilè sbottonato, aiutava qua e là e tirava madonne e schiaffi sulle teste. Gli uomini, seminudi, lucidi di fatica, mischiavano la gomma al carbomblecco, alle arilammine e diarilammine, all’acido stearico, agli oli, ai fenoli, tiravano dai magazzini le crêpe e le balle di caucciù e le preziose gomme sintetiche, e stampavano e stampavano, mentre la pressa s’alzava e s’abbassava e lo zolfo vulcanizzava, trasformando l’inerte sostanza nel magico composto elastico e benigno.
Calava la notte, la produzione avanzava, scemavano le scorte ad una ad una. E nel mentre, a Verdognola, cresceva l’agitazione. Qualcuno, indiscreto e previdente, aveva visto, aveva udito, aveva dedotto. Il barbiere D’Arrigò, stretto d’assedio fra innumeri ceffi deformati dall’ira, aveva confessato.
Già un capannello sparuto sostava al cancello della ditta Carnemolla, guatato con bonario sospetto dall’occhio vigile dell’effigie rosea e paffuta del fu cavalier Guido, e di lontano, alla spicciolata, giungevano lunghe ombre curva nel crepuscolo.
Già in paese s’erano gonfiate camere d’aria usate e palloni e palloncini, svuotati e tappati innumeri bottiglie, bottiglioni e fiaschi, vasi barattoli e vasetti, damigiane, orciuoli e otri, botti, borracce e botticine, oliere e bottigliette, flaconi e profumiere. E in farmacia non era più disponibile un certo prodotto di cui, in altri normali tempi, si rifuggiva il peccaminoso nome foriero d’amori clandestini. Già s’era provveduto a rendere ermetici infissi, porte e finestre, camini e sfiatatoi, sigillandoli in mille e un modo.
Ed ora, che le tenebre calavano, gli animi si sentivano frugare dalle gelide unghie spezzate della paura e del terrore e tutti trattenevano tremanti il fiato levando gli occhi al cielo greve e coperto, percorso da nubi più nere del nero, minacciose e funebri più del lugubre gufare del gufo. Mentre una folla sempre più vasta, gremita e rumoreggiante, s’andava addensando minacciosa ai cancelli della «Fu Guido cavalier Carnemolla e figlio».
CAPITOLO QUARTO
In attesa dell’ultima catastrofe
Finché arrivò il giorno della fine del mondo.
Nel breve volgere di poche ore, dai primissimi pentimenti della notte, quando appena si distingue ciò che si staglia contro il cielo, fino al terminar dell’alba, il lavoro d’un giorno e d’una notte, il lavoro di quindici operai e del cavalier Rosmindo Carnemolla, dei suoi figli, dei tre impiegati e fin della segretaria Alessia, più il rappresentante gengivuto, tanto instancabile lavoro aveva fruttato, a esaurimento della materia prima e del prodotto finito, tranne la necessaria, improcrastinabile scorta a previdente uso proprio, dieci venti cento volte di più del calcolato. Il Carnemolla era al settimo cielo: salvato il mondo, seppur nella misera fattispecie di Verdognola, guadagnata una fortuna, assicurata la sopravvivenza propria e della stirpe.
Fu un giorno, quell’ultimo giorno della fine del mondo, grigio e chiuso come tutti i precedenti, ma battuto stavolta da una pioggia insistente e maligna. Verdognola era deserta, le strade coperte da un velo di fango puteolente e nerastro. I lampioni ancora accesi, abbandonati a sbadigliare vanamente la loro luce sul selciato, erano vestiti d’un malinconico alone di gioielli giallini. Santippe, cane bastardo e rognoso, sorta di lupo incivilito, incrociava funesto le vie, ciondolando la coda zuppa e spelacchiata, rasente i muri, studioso dei porticati. I verdognolesi s’erano barricati tappati sigillati ermetizzati nelle loro case, circondati dai neri grossi serpenti rigonfi dei pneumatici carnemolla gonfi d’aria e di sopravvivenza. Gesualdo Squillace, agrimensore e commerciante al dettaglio, di crassa famiglia e di gran lunga il più ricco del paese, non disponeva ormai d’altro nella vasta casa, avendo venduto ogni suo bene, dai terreni alle suppellettili esotiche, per assicurasi un lungo abbondante futuro gonfio d’aria, e mirava ansioso oltre il vetro unto della finestra del salotto buono, fra il riflesso del lampadario settecentesco. Proteo, il cencioso mendicante avvinazzato e folle, accucciato nel più riposto canto dei portici di Piazza Inpendenza o Morte, teneva il volto rivolto ad un secchio cui era fissata un’incerata logora e consunta, passantegli sul capo e perfettamente stagna, a mo’ di come aveva visto fare da un dagherrotipista giunto di lontano per immortalar in lastra reperti di un ingeneroso passato.
Tutti, nessuno ormai più ricco e tutti ugualmente miseri nel terrore, attendevano silenti e immoti.
Passavano le ore e non c’era quasi modo di saperlo: padre Rosalio vagava nella sacrestia frusciano nella veste e cincischiando con la cotta immerlettata, il sacrestano lo fissava inebetito e assente, seminascosto fra le gomme; pochi avevano resistito alla tentazione di scambiare orologi da polso, da taschino, pendole e cucù per una camera d’aria; e l’unico ticchettio che si sentiva nelle case sepolcralmente silenziose era quello della pioggia sui vetri, e dell’anobio in calore nelle sue oscure gallerie in mobili ed infissi.
E scese la notte, pioveva ancora.
Qualcuno piangeva sul capo dei figli o della moglie, qualcuno rivedeva i peccati trascorsi. L’oste Sigfrido giocava a briscola con l’amante al lume d’una mezza candela di sego. Molti bagnavano e mordevano il cuscino di singulti e lacrime. All’avvocato Ricciardini tremava a mezz’aria la tazzina del caffè sbrodolandogli il panciotto, qualcuno dormiva, nelle grandi case coloniche i giovani tentavano l’ultimo decisivo indomito assalto alla gelida virtù delle donzelle. Domani potrebbe essere troppo tardi.
Poi le luci. Ad una ad una. A grappoli, a singhiozzo, pentite, recidive, incerte, rade, frenetiche. Si spensero tutte. E restarono solo il buio e la pioggia a coprire Verdognola, mentre la cometa rollava, beccheggiava, sibilava velocissima nell’etere, sempre più vicina, sempre più vicina.
Sempre più vicina.
EPILOGO
Tempeste d’uomini peggiori di quelle degli Oceani
Il contino Guglielmo aveva ripreso le sue ascetiche abitudini e, dall’alba, rimirava il canale oltre l’alto muro di confine dell’avita magione, bagnato ancora dalla pioggia che durava instancabile e diaccia. Non aveva dormito, quella notte, nella vana attesa di poter osservare il prodigioso trascorrere della cometa, traverso il precisissimo, ineguagliato, superbo telescopio da generazioni in uso presso la famiglia nobiliare. L’evento stellare non s’era neppure veduto, se non in fantasmatica sembianza, e il contino Guglielmo aveva vegliato, si può ben dire, inutilmente.
C’era stato, è vero, un subito trascolorare del denso cielo, a meridione, ma fu come una candela che passasse repentina di là da una tenda spessa. Un lampo lontano, un lucore diffuso. Poi, solo per un attimo, per un attimo solo, era apparso tra le nubi grasse lo scintillio di bianco argento della sua coda, fugace e perduto come il sorriso di una donna che non si potrà mai amare. E al contino non sarebbe mai più stata offerta la medesima occasione; il bolide celeste possedeva un periodo di rivoluzione troppo lungo anche per la memoria degli uomini, e le sue apparizioni erano testimoniate solo da sparse cronache sempre più fumose e sempre più lontane nel passato. Incerte, frammentarie. Che ad un’analisi attenta rivelavano la stessa indeterminatezza e variabilità dei passaggi periodici.
Così il contino Guglielmo, svaporato dalla notte insonne, la scimmietta Eberarda sulla spalla, osservava il canale grigio battuto dalla pioggia. Smarrito, deludo, uggioso. E osservava anche, via via incredulo e dubbioso, uno strano e quanto mai singolare fenomeno acustico e visivo formarsi sul finire della strada conducente, di sopra l’argine, al paese. C’era lì in fondo, indistinto fra la pioggia battente, un nugolo vorticante e formicolante di figure nere e grigie, dimenanti lunghe antenne, che s’appressavano veloci e mostruose come sciame immondo e brulicante. Macinando feroce la ghiaia della via, schizzando l’acqua e il fango della terra come sotto una pressione potente, il mostro emetteva uno stridio acuto e bizzarro come di nere lucenti elitre chitinose e durissime.
Ben presto fu a vista. E l’orrido essere irto d’aculei si rivelò composto d’esseri umani, urlanti in preda al panico o all’odio, al terrore o al ludibrio. S’alzavano grida di dolore e cachinni osceni, e il contino Guglielmo, attonito e curioso, non si capacitava di ciò che udiva e vedeva.
Presto la massa fu vicina. Anticipava tutti una veloce e scarmigliata figura vestita d’uno svolazzante e leggero camice bianco, urlante e quasi strombazzante come un folle araldo d’altri tempi. Poi, un po’ alla volta, passarono veloci tutti gli altri, tutti gli abitanti di Verdognola, forsennatamente scalpitanti. Dagli irrefrenabili giovani ai prestanti anziani, fino allo scalmanato e claudicante buon ultimo Proteo, dimenante le braccia e in preda ad una devastante tosse, urlante a tratti: «morte alla serpe in seno!» «Satana ipocrita e mentitore!» «barbiere affamatore» e, con tono piagnucoloso: «rovinati, tutti rovinati… piove!».
Il contino carezzò Eberarda sotto il mento, sbottò incredulo e ignaro, brontolò alcune indecifrabili sillabe e volse le spalle alla finestra, al canale, all’incomprensibile demenza dei suoi contemporanei e concittadini.
Qualche mezzo chilometro più indietro, nel suo ufficio in mogano e noce, il cavalier Rosmindo si fregava le manone, saltellava sulle gambette secche e ridacchiava: «Ci ho colpa, io? Ci ho colpa?»